SCAFFALE LECCHESE/241: 'Quando muore un comunista', un romanzo che avrebbe meritato fortuna
Settant’anni fa, «finito di stampare il 31 luglio 1955», appariva un libro oggi purtroppo dimenticato e che varrebbe forse la pena di riscoprire. Avrebbe già allora meritato un pubblico più vasto di quello che probabilmente ebbe, uscendo come uscì per le “Edizioni Avanti!”: autorevoli, ma decisamente di nicchia. Non sfigurerebbe, ancora oggi, tra i romanzi “maggiori” della letteratura italiana dedicati all’immediato secondo dopoguerra. 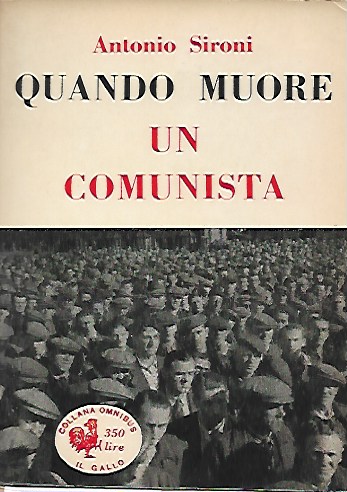 Stiamo parlando di “Quando muore un comunista”. Lo scrisse un lecchese dalla vita inquieta: Antonio Sironi, operaio, prete mancato e poi docente di latino e greco.
Stiamo parlando di “Quando muore un comunista”. Lo scrisse un lecchese dalla vita inquieta: Antonio Sironi, operaio, prete mancato e poi docente di latino e greco.
Nato nel 1912 a Pescarenico in una famiglia operaia, giovanissimo entrò in fabbrica a Valmadrera, prima di inseguire una vocazione religiosa che si sarebbe rivelata fragile: a sedici anni entrò in seminario studiando a Monza e a Venegono, ma fuggendone alla vigilia di Natale del 1930, pochi giorni prima dell’ordinazione. Tornò a fare l’operaio, in una fabbrica di marmi a Lecco, pur continuando gli studi, riuscendo nel 1940 a laurearsi in Lettere (successivamente conseguirà una seconda laurea in Filosofia).
Durante la guerra fu arruolato e dopo l’8 settembre 1943 riparò in Svizzera, dove collaborò con personaggi del calibro di Giorgio Strehler e Paolo Grassi ad animare il campo degli artisti italiani internati. Lavorò come manovale a Ginevra e come muratore a Berna
Rientrato in Italia all’indomani della Liberazione, insegnò a Lecco: latino e greco al liceo classico “Manzoni”, cultura generale ai corsi serali della scuola professionale dell’Elip, così all’epoca si chiamava quella che sarebbe diventata l’istituto “Fiocchi”, Si trasferì poi a Milano, insegnando al liceo classico “Parini” e dirigendo anche il convitto-scuola della Rinascita, una scuola rivolta ad ex partigiani ed ex deportati e ai loro figli, attiva dal 1945 alla metà degli anni Cinquanta. Morì a Milano nel 1982.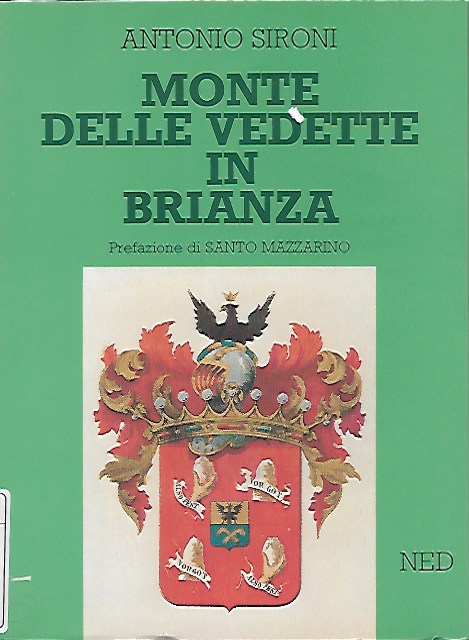 Di lui restano quel romanzo del 1955 e una storia di Montevecchia, “Il Monte delle vedette in Brianza”, «che ha certamente la colpa di essere tutto e troppo: erudizione e racconto, storia e narrazione, ma ha, credo, anche una giustificazione: là, a Montevecchia, è nato mio padre, là ho passato la fanciullezza, là ho conosciuto, nel tempo, la brevità e la irripetibilità dell’esistenza individuale». Così scriveva lo stesso Sironi che non riuscì a vederne la pubblicazione. Il libro sarebbe infatti uscito dai torchi della milanese Ned (Nuove Edizioni Duomo) solo nel 1983.
Di lui restano quel romanzo del 1955 e una storia di Montevecchia, “Il Monte delle vedette in Brianza”, «che ha certamente la colpa di essere tutto e troppo: erudizione e racconto, storia e narrazione, ma ha, credo, anche una giustificazione: là, a Montevecchia, è nato mio padre, là ho passato la fanciullezza, là ho conosciuto, nel tempo, la brevità e la irripetibilità dell’esistenza individuale». Così scriveva lo stesso Sironi che non riuscì a vederne la pubblicazione. Il libro sarebbe infatti uscito dai torchi della milanese Ned (Nuove Edizioni Duomo) solo nel 1983.
Risale invece agli anni Trenta “La città del malaffare”, un romanzo mai pubblicato e andato irrimediabilmente perduto. E’ il romanzo di cui parlava anche l’avvocato lecchese Franco Calvetti quando ricordava le serate giovanili trascorse tra la trattoria Concordia e la bottigliera Valsecchi in compagnia di Sironi, del pittore Ennio Morlotti e del poeta Luigi Capelli: «“La città del malaffare” era la Lecco di allora» e il romanzo «era roba da andare in galera».
“Quando muore un comunista” racconta la storia di Antonio Fanti, “Toni”, figlio di un ferroviere e di una vestitrice di morti. Dopo sei anni come ufficiale nell’Esercito italiano, all’indomani dell’8 settembre 1943, Toni viene arrestato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento in Cecoslovacchia. Finita la guerra, torna in Italia passando per l’Austria dove conosce Edy: lui ha 34 anni e lei 20, ma si sposeranno e lei lo seguirà in Italia. Lui insegna, proprio latino a greco al liceo classico di una cittadina di provincia poco distante da Milano. Come dunque non vedere in Toni se non un vero e proprio alter ego dell’autore, quando meno una sua proiezione?
Già nell’autunno del 1945. Toni si iscrive al Pci: «Oggi mi sono iscritto al Partito comunista. So di essere ben lontano dall’essere un comunista ma intuisco che cosa e chi è un comunista; ed appunto per questo e in vista di questo mi sono deciso. Voglio vivere una vita felice con una moglie felice e so che questo non è possibile da noi soli. L’abbraccio solitario di un uomo e una donna è uno scoglio troppo logorabile dalle onde del dolore e del disordine che ci circondano».
Si getta nell’attività politica e vorrebbe che Edy facesse altrettanto. Ma in lei il sacro fuoco non arde: «Io provavo un bisogno prepotente di difendere gli altri; quelli che non erano del Partito. Quelli che erano come ero io».
Ne nascono inevitabili incomprensioni che sfociano in una sorta di separazione. Edy si trasferisce per qualche tempo a Londra per perfezionare l’inglese. E a Londra avvengono alcuni incontri fondamentali, Edy incrocia il movimento dei Partigiani per la pace e resta suo malgrado coinvolta nella rocambolesca fuga di uno scienziato sospettato di essere una spia russa.
E’ impossibile, qui, tracciare anche solo grossolanamente il contesto politico di quegli anni che a livello internazionale sono quelli dell’avvio della guerra fredda e in Italia la fase della ricostruzione e della trasformazione industriale del Paese, con le tensioni sociali che si aggiungono agli strascichi della seconda guerra mondiale e del fascismo. Nonché dello scontro tra mondo cattolico e mondo comunista.
Quando Edy torna da Toni si apre una nuova fase nella vita dei due coniugi che finalmente si “incontrano”, ma è una frase di breve durata: Toni muore infatti il 27 marzo 1952, dalla sventagliata di mitra di un poliziotto mentre si trova davanti a una fabbrica in sciopero.
“Quando muore un comunista” è naturalmente un romanzo politico (e schierato), molti sono dunque gli spunti di discussione.
Ci sono le considerazioni del Toni militante: «Ma possibile che voi riusciate a nascondere a voi stessi che gli operai hanno paura, non credono più al giochetto della solidarietà da quando si sono accorti che il bel tempo è finito. Che i padroni sono tornati i padroni e che ormai è l’ora di tirare i remi in barca per chi non è fesso e non vuol lasciarci le ossa? (…) Solo i deboli non sano decidersi da loro e lasciano che il male li investa come una fatale valanga».
E quelle del Toni professore: «Stimolo il giudizio critico dei miei alunni sulle persone, cose ed istituzioni che li circondano – padre, madre, professori, parroco, sindaco, operai, impiegati e poliziotti - indicando loro come punto di riferimento e criterio di valutazione il denaro di cui costoro dispongono e le condizioni in cui se ne appropriano. Metto a profitto il presente naturale antagonismo del giovane per una società come la nostra che imprigiona e soffoca ogni sua espansione, svelo la ragnatela di brutale interesse e di dispotica ingordigia che condiziona le loro speranze e i loro affetti fino a quando la loro spontanea generosità non ancora corrotta dalla rassegnazione e dalla paura, li compromette. Ed agiscono. Piccole ribellioni: tempestose denunce. Ed imparano da soli che vivere non è conoscere i ritmi secondo cui batte il cuore fatale della natura ma manomettere questo cuore»
Si aggiungono le riflessioni di Edy: «Non ho tardato a rendermi conto che in Italia, al contrario di quanto succede nei paesi non cattolici, i principi e i metodi educativi risentono del vizio che corrode tutta la società italiana: il paternalismo e il precettismo classico dei modelli perfetti. Per i paesi a sottofondo classicistico, come l’Italia, solo l’uomo adulto e l’uomo ricco sono esseri completi, il bambino e il povero sono qualcosa di informe, di infelice, di mutilato. Di qui il paternalismo.»
Romanzo politico, dunque, ma non solo. Anzi. Forse ancora di più è anche un romanzo sulla complessità degli affetti e dell’amore, dei rapporti personali. Non è un caso che la storia di Edy e Toni si intreccia con la relazione tra una giovane studentessa e un sacerdote, relazione che non diventa carnale ma che vede i due camminare sull’orlo di un autentico abisso.
La voce narrante è quella di Edy, mentre l’animo tormentato di Toni emerge da lettere e appunti che lascia e che la moglie conserva e rilegge in occasione di un altro sciopero, quello che la vede impegnata in prima persona a Milano, dove si è trasferita dopo la morte del marito.
Attraverso i suoi personaggi, Sironi ha riflettuto sul rapporto tra individuo e società che è tema ancora attuale oggi ed è forse tema eterno.
Come quando Toni pensa al proprio rapporto con Edy: «Volevo essere l’eroe del mio matrimonio e sono un comune avido amante malato di gelosia carnale». Del resto, «ritengo che anche tu Edy, anche tu come tutta questa decaduta società borghese di individui isolati pensi che l’uomo non ha alcuna “missione” generale, nessun “compito” salvo quello di utilizzare la sua forza di appropriazione; vivere – come si suol dire – la propria vita». Ma dopo la morte di Toni, a Edy rimane «una scoperta e un insegnamento, questo: che se muore di fame un bambino nel Kenya, se un negro viene massacrato nel Kansas o se un canale viene costruito in Cina, tutto questo ci tocca da vicino, ci riguarda personalmente.» E ancora: «Le cose che si fanno, prima di essere torti o ragioni, sono passi allungati l’un dopo l’altro sul nostro cammino». C’è «un’economia di bisogni, di sforzi e desideri che va oltre le nostre persone e in cui – a nostra insaputa - si inseriscono i nostri compiti e il nostro destino».
La piccola cittadina lombarda è anonima, indicata con una “X”, così da farla assurgere a paradigma di una qualsiasi città della provincia lombarda contraddistinta da un’«atmosfera retriva e reazionaria della borghesia». Ma in quella città indefinita ci sono il lago e le montagne, i pescatori, «l’acqua dei nostri torrenti», un’acciaieria e ferriera, una fabbrica di lampadine, una di esplosivi e un’altra che si chiama “Metalli Carbone”. Un quadro a noi lecchesi troppo noto. Come ci sono noti alcuni degli episodi raccontati: un processo penale contro la Camera del lavoro nel 1948 e lo sciopero fallito nella grande acciaieria con il licenziamento della commissione interna.
L’uno e l’altro sono infatti vicende reali della storia lecchese alle quali si è anche accennato in questa rubrica.
Il primo evoca l’arresto di quattordici dirigenti sindacali a conclusione di un’indagine sull’aggressione del segretario dalla Camera del lavoro, Gabriele Invernizzi da parte di un industriale.
Il secondo è la vertenza durissima che si svolse al Caleotto conclusa con uno sciopero fallito e il licenziamento collettivo di diversi rappresentanti sindacali, tra i quali Pio Galli.
Lo sciopero risale in realtà al 1953: se a quella data il protagonista Toni è già morto da un anno, Sironi ne è in qualche modo testimone e “Quando muore un comunista” uscirà nel 1955: e dunque nell’immaginaria città di “X” può ben accadere un anno prima.
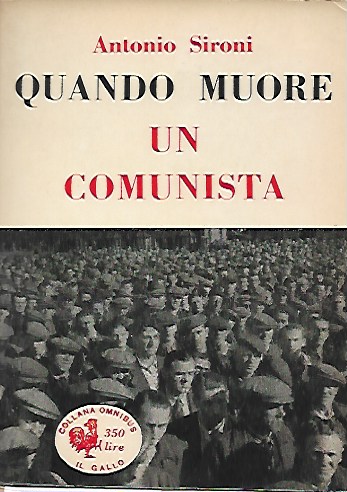
Nato nel 1912 a Pescarenico in una famiglia operaia, giovanissimo entrò in fabbrica a Valmadrera, prima di inseguire una vocazione religiosa che si sarebbe rivelata fragile: a sedici anni entrò in seminario studiando a Monza e a Venegono, ma fuggendone alla vigilia di Natale del 1930, pochi giorni prima dell’ordinazione. Tornò a fare l’operaio, in una fabbrica di marmi a Lecco, pur continuando gli studi, riuscendo nel 1940 a laurearsi in Lettere (successivamente conseguirà una seconda laurea in Filosofia).
Durante la guerra fu arruolato e dopo l’8 settembre 1943 riparò in Svizzera, dove collaborò con personaggi del calibro di Giorgio Strehler e Paolo Grassi ad animare il campo degli artisti italiani internati. Lavorò come manovale a Ginevra e come muratore a Berna
Rientrato in Italia all’indomani della Liberazione, insegnò a Lecco: latino e greco al liceo classico “Manzoni”, cultura generale ai corsi serali della scuola professionale dell’Elip, così all’epoca si chiamava quella che sarebbe diventata l’istituto “Fiocchi”, Si trasferì poi a Milano, insegnando al liceo classico “Parini” e dirigendo anche il convitto-scuola della Rinascita, una scuola rivolta ad ex partigiani ed ex deportati e ai loro figli, attiva dal 1945 alla metà degli anni Cinquanta. Morì a Milano nel 1982.
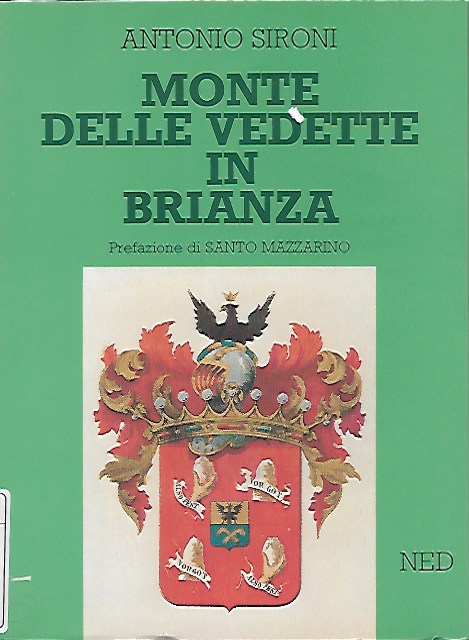
Risale invece agli anni Trenta “La città del malaffare”, un romanzo mai pubblicato e andato irrimediabilmente perduto. E’ il romanzo di cui parlava anche l’avvocato lecchese Franco Calvetti quando ricordava le serate giovanili trascorse tra la trattoria Concordia e la bottigliera Valsecchi in compagnia di Sironi, del pittore Ennio Morlotti e del poeta Luigi Capelli: «“La città del malaffare” era la Lecco di allora» e il romanzo «era roba da andare in galera».
“Quando muore un comunista” racconta la storia di Antonio Fanti, “Toni”, figlio di un ferroviere e di una vestitrice di morti. Dopo sei anni come ufficiale nell’Esercito italiano, all’indomani dell’8 settembre 1943, Toni viene arrestato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento in Cecoslovacchia. Finita la guerra, torna in Italia passando per l’Austria dove conosce Edy: lui ha 34 anni e lei 20, ma si sposeranno e lei lo seguirà in Italia. Lui insegna, proprio latino a greco al liceo classico di una cittadina di provincia poco distante da Milano. Come dunque non vedere in Toni se non un vero e proprio alter ego dell’autore, quando meno una sua proiezione?
Già nell’autunno del 1945. Toni si iscrive al Pci: «Oggi mi sono iscritto al Partito comunista. So di essere ben lontano dall’essere un comunista ma intuisco che cosa e chi è un comunista; ed appunto per questo e in vista di questo mi sono deciso. Voglio vivere una vita felice con una moglie felice e so che questo non è possibile da noi soli. L’abbraccio solitario di un uomo e una donna è uno scoglio troppo logorabile dalle onde del dolore e del disordine che ci circondano».
Si getta nell’attività politica e vorrebbe che Edy facesse altrettanto. Ma in lei il sacro fuoco non arde: «Io provavo un bisogno prepotente di difendere gli altri; quelli che non erano del Partito. Quelli che erano come ero io».
Ne nascono inevitabili incomprensioni che sfociano in una sorta di separazione. Edy si trasferisce per qualche tempo a Londra per perfezionare l’inglese. E a Londra avvengono alcuni incontri fondamentali, Edy incrocia il movimento dei Partigiani per la pace e resta suo malgrado coinvolta nella rocambolesca fuga di uno scienziato sospettato di essere una spia russa.
E’ impossibile, qui, tracciare anche solo grossolanamente il contesto politico di quegli anni che a livello internazionale sono quelli dell’avvio della guerra fredda e in Italia la fase della ricostruzione e della trasformazione industriale del Paese, con le tensioni sociali che si aggiungono agli strascichi della seconda guerra mondiale e del fascismo. Nonché dello scontro tra mondo cattolico e mondo comunista.
Quando Edy torna da Toni si apre una nuova fase nella vita dei due coniugi che finalmente si “incontrano”, ma è una frase di breve durata: Toni muore infatti il 27 marzo 1952, dalla sventagliata di mitra di un poliziotto mentre si trova davanti a una fabbrica in sciopero.
“Quando muore un comunista” è naturalmente un romanzo politico (e schierato), molti sono dunque gli spunti di discussione.
Ci sono le considerazioni del Toni militante: «Ma possibile che voi riusciate a nascondere a voi stessi che gli operai hanno paura, non credono più al giochetto della solidarietà da quando si sono accorti che il bel tempo è finito. Che i padroni sono tornati i padroni e che ormai è l’ora di tirare i remi in barca per chi non è fesso e non vuol lasciarci le ossa? (…) Solo i deboli non sano decidersi da loro e lasciano che il male li investa come una fatale valanga».
E quelle del Toni professore: «Stimolo il giudizio critico dei miei alunni sulle persone, cose ed istituzioni che li circondano – padre, madre, professori, parroco, sindaco, operai, impiegati e poliziotti - indicando loro come punto di riferimento e criterio di valutazione il denaro di cui costoro dispongono e le condizioni in cui se ne appropriano. Metto a profitto il presente naturale antagonismo del giovane per una società come la nostra che imprigiona e soffoca ogni sua espansione, svelo la ragnatela di brutale interesse e di dispotica ingordigia che condiziona le loro speranze e i loro affetti fino a quando la loro spontanea generosità non ancora corrotta dalla rassegnazione e dalla paura, li compromette. Ed agiscono. Piccole ribellioni: tempestose denunce. Ed imparano da soli che vivere non è conoscere i ritmi secondo cui batte il cuore fatale della natura ma manomettere questo cuore»
Si aggiungono le riflessioni di Edy: «Non ho tardato a rendermi conto che in Italia, al contrario di quanto succede nei paesi non cattolici, i principi e i metodi educativi risentono del vizio che corrode tutta la società italiana: il paternalismo e il precettismo classico dei modelli perfetti. Per i paesi a sottofondo classicistico, come l’Italia, solo l’uomo adulto e l’uomo ricco sono esseri completi, il bambino e il povero sono qualcosa di informe, di infelice, di mutilato. Di qui il paternalismo.»
Romanzo politico, dunque, ma non solo. Anzi. Forse ancora di più è anche un romanzo sulla complessità degli affetti e dell’amore, dei rapporti personali. Non è un caso che la storia di Edy e Toni si intreccia con la relazione tra una giovane studentessa e un sacerdote, relazione che non diventa carnale ma che vede i due camminare sull’orlo di un autentico abisso.
La voce narrante è quella di Edy, mentre l’animo tormentato di Toni emerge da lettere e appunti che lascia e che la moglie conserva e rilegge in occasione di un altro sciopero, quello che la vede impegnata in prima persona a Milano, dove si è trasferita dopo la morte del marito.
Attraverso i suoi personaggi, Sironi ha riflettuto sul rapporto tra individuo e società che è tema ancora attuale oggi ed è forse tema eterno.
Come quando Toni pensa al proprio rapporto con Edy: «Volevo essere l’eroe del mio matrimonio e sono un comune avido amante malato di gelosia carnale». Del resto, «ritengo che anche tu Edy, anche tu come tutta questa decaduta società borghese di individui isolati pensi che l’uomo non ha alcuna “missione” generale, nessun “compito” salvo quello di utilizzare la sua forza di appropriazione; vivere – come si suol dire – la propria vita». Ma dopo la morte di Toni, a Edy rimane «una scoperta e un insegnamento, questo: che se muore di fame un bambino nel Kenya, se un negro viene massacrato nel Kansas o se un canale viene costruito in Cina, tutto questo ci tocca da vicino, ci riguarda personalmente.» E ancora: «Le cose che si fanno, prima di essere torti o ragioni, sono passi allungati l’un dopo l’altro sul nostro cammino». C’è «un’economia di bisogni, di sforzi e desideri che va oltre le nostre persone e in cui – a nostra insaputa - si inseriscono i nostri compiti e il nostro destino».
La piccola cittadina lombarda è anonima, indicata con una “X”, così da farla assurgere a paradigma di una qualsiasi città della provincia lombarda contraddistinta da un’«atmosfera retriva e reazionaria della borghesia». Ma in quella città indefinita ci sono il lago e le montagne, i pescatori, «l’acqua dei nostri torrenti», un’acciaieria e ferriera, una fabbrica di lampadine, una di esplosivi e un’altra che si chiama “Metalli Carbone”. Un quadro a noi lecchesi troppo noto. Come ci sono noti alcuni degli episodi raccontati: un processo penale contro la Camera del lavoro nel 1948 e lo sciopero fallito nella grande acciaieria con il licenziamento della commissione interna.
L’uno e l’altro sono infatti vicende reali della storia lecchese alle quali si è anche accennato in questa rubrica.
Il primo evoca l’arresto di quattordici dirigenti sindacali a conclusione di un’indagine sull’aggressione del segretario dalla Camera del lavoro, Gabriele Invernizzi da parte di un industriale.
Il secondo è la vertenza durissima che si svolse al Caleotto conclusa con uno sciopero fallito e il licenziamento collettivo di diversi rappresentanti sindacali, tra i quali Pio Galli.
Lo sciopero risale in realtà al 1953: se a quella data il protagonista Toni è già morto da un anno, Sironi ne è in qualche modo testimone e “Quando muore un comunista” uscirà nel 1955: e dunque nell’immaginaria città di “X” può ben accadere un anno prima.
Dario Cercek















