SCAFFALE LECCHESE/196: Martino e i valsassinesi alla seconda Crociata
I valsassinesi alla seconda Crociata. Un episodio storico ormai già da secoli circonfuso di leggenda è lo spunto per un racconto del premanese Carlo Del Teglio (1926-1988): “Il guerriero e l’eremita”, stampato dalla lecchese Grafiche Maggioni in una data imprecisata (probabilmente negli anni Ottanta). Di Del Teglio ci siamo già occupati a proposito del racconto “Il fabbro e la fortuna”. Nel “Guerriero e l’eremita” si parla di Martino Della Torre. Signore di Valsassina, guidò la spedizione che partì da Primaluna nella primavera del 1147 per raggiungere la Terra Santa. Al seguito c’erano i feudatari delle vallate e del lago, ma anche gente umile: «non era nemmeno un esercito d’uomini induriti dalla guerra, ma piuttosto un pellegrinaggio armato, un’accolta di gente spinta a quel viaggio da un fervore religioso molto vicino al fanatismo. Una moltitudine del tutto ignara di strategia militare, se si fa eccezione per pochi uomini d’arme, appartenenti al ceto feudale, ch’erano i soli a saper maneggiare la spada. Al popolo, ai vassalli, era giuridicamente inibito, del resto, il porto d’armi, privilegio della nobiltà».
Nel “Guerriero e l’eremita” si parla di Martino Della Torre. Signore di Valsassina, guidò la spedizione che partì da Primaluna nella primavera del 1147 per raggiungere la Terra Santa. Al seguito c’erano i feudatari delle vallate e del lago, ma anche gente umile: «non era nemmeno un esercito d’uomini induriti dalla guerra, ma piuttosto un pellegrinaggio armato, un’accolta di gente spinta a quel viaggio da un fervore religioso molto vicino al fanatismo. Una moltitudine del tutto ignara di strategia militare, se si fa eccezione per pochi uomini d’arme, appartenenti al ceto feudale, ch’erano i soli a saper maneggiare la spada. Al popolo, ai vassalli, era giuridicamente inibito, del resto, il porto d’armi, privilegio della nobiltà».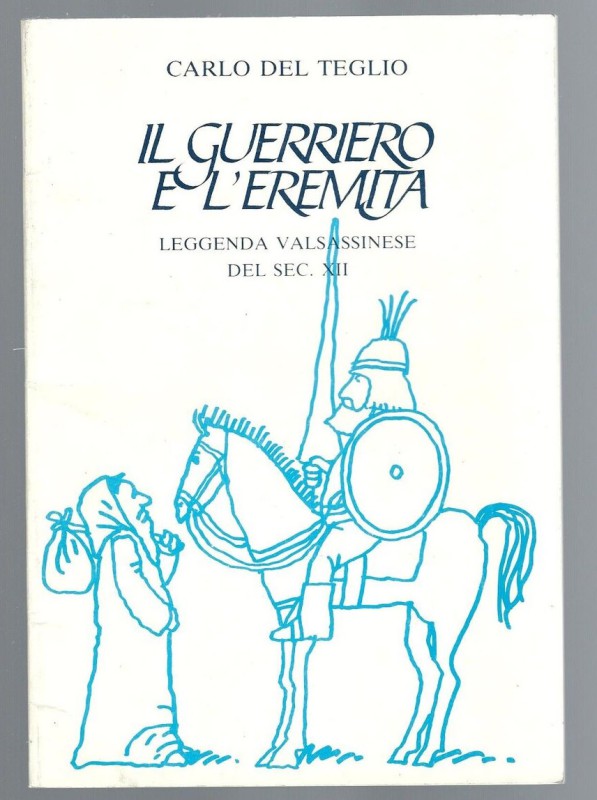 Questa folla indefinita prese la via della Germania per unirsi all’imperatore Corrado, ma «si può facilmente immaginare a quali immane fatiche e disagi andava incontro (…) e si può anche pensare a quali condizioni disastrose, e quanto seminate d’ogni sorta di pericoli, fossero le strade d’allora» e soprattutto i valichi alpini: «Ghiacci e valanghe erano rischi d’ogni giorno. E tormente e fame e freddo». E «già qualcuno cominciava a rimanere per strada, stremato dalla fatica e dal freddo, o sprofondato in qualche burrone. Era rimasto solo il frate cistercense a prodigarsi nel rincuorare e stimolare la fede folle di quegli sciagurati, che troppo tardi s’accorgevano d’essersi avventurati in un’impresa superiore alle loro forze. Ma ogni giorno la sua mano scarna doveva alzarsi a benedire l’ennesima salma, rimasta abbandonata sul bianco manto di neve, che presto sarebbe diventato la sua tomba».
Questa folla indefinita prese la via della Germania per unirsi all’imperatore Corrado, ma «si può facilmente immaginare a quali immane fatiche e disagi andava incontro (…) e si può anche pensare a quali condizioni disastrose, e quanto seminate d’ogni sorta di pericoli, fossero le strade d’allora» e soprattutto i valichi alpini: «Ghiacci e valanghe erano rischi d’ogni giorno. E tormente e fame e freddo». E «già qualcuno cominciava a rimanere per strada, stremato dalla fatica e dal freddo, o sprofondato in qualche burrone. Era rimasto solo il frate cistercense a prodigarsi nel rincuorare e stimolare la fede folle di quegli sciagurati, che troppo tardi s’accorgevano d’essersi avventurati in un’impresa superiore alle loro forze. Ma ogni giorno la sua mano scarna doveva alzarsi a benedire l’ennesima salma, rimasta abbandonata sul bianco manto di neve, che presto sarebbe diventato la sua tomba».
Superate le Alpi, l’“armata” valsassinese non riuscì a incontrarsi con quella di Corrado che era già troppo avanti lungo la strada verso il Santo Sepolcro. Discese allora solitaria i Balcani: «Man mano che procedeva si rendeva conto che, in fondo, il fatto d’esser preceduto da un esercito ben più numeroso e temibile del suo poteva, in certo modo, ritenersi una fortuna. A volte infatti doveva provvedere con razzie e scorribande all’approvvigionamento delle vettovaglie, ma spesso accadeva che gli abitanti delle varie regioni offrissero spontaneamente viveri e bevande alla nuova armata in transito, per evitare maggiori danni, a ciò persuasi dall’esperienza dei precedenti passaggi, di cui rimanevano tracce fin troppo eloquenti. Villaggi interi che avevano opposto resistenza all’esercito cristiano erano stati incendiati e distrutti. Le loro rovine si scorgevano ancora fumanti, e non lasciavano alcun dubbio sull’itinerario seguito dalle armate dell’Imperatore e degli altri Principi crociati».
A Konya in Cappadocia, la spedizione valsassinese fu assalita dai soldati del sultano: «Ne seguì una strage orribile. Gli ultimi gruppi di donne e bambini, i resti scampati al lungo e durissimo pellegrinaggio, finirono miseramente trucidati i furono presi prigionieri».
I sopravvissuti raggiunsero infine Damasco dove Martino si comportò da eroe tanto da meravigliare lo stesso nemico: «Nella sua vita, il Sultano ne aveva conosciuti di guerrieri prodi e valorosi, ma un simile esemplare, un combattente di tanto coraggio e intrepidezza lo riempiva di stupore e d’inaudita ammirazione». Martino fu poi catturato e, rifiutandosi di abiurare la fede cristiana, venne decapitato».
Queste dunque le “glorie” del prode cavaliere valsassinese. Nel suo racconto, però, Del Teglio inserisce un personaggio in qualche modo contrapposto al “guerriero” Martino e cioè l’“eremita” Landino, ma eremita nel senso di solitario e quasi selvatico: «nell’insieme presentava un aspetto deplorevole. Piccolo e deforme nelle membra, l’andatura sciancata, coperto, più che vestito, di panni grossolani e laceri, sembrava un mostriciattolo». Da tempo, aveva lasciato il consesso umano per rifugiarsi sui monti, in compagnia solo delle sue capre e aiutando tutti quegli animali che in varia misura avevano bisogno d’essere soccorsi. Guardando la valle dall’alto, Landino assistette alla partenza dei crociati valsassinesi e «un malessere «strano lo teneva inchiodato», come una sorta di presentimento. Del resto, nello stesso momento in cui Martino moriva a Damasco, Landino spirava in Valsassina.
A questo punto, il nostro autore sposta la scena del racconta nientemeno che in Paradiso nel momento in cui angeli e cherubini accoglievano Martino, «caduto sulle mura damascene per mano mussulmana, invitto campione e testimone della fede in Cristo»; dietro di lui «procedeva una compagnia di guerrieri con lui caduti sul campo di battaglia, ognuno con la sua fiammeggiante rosa di sangue sul candore della tunica crociata, ognuno inalberando il suo vessillo. Facevan ala al loro passaggio schiere reverenti d’angeliche guardie, mentre in coda seguiva l’orchestra, in ordine perfetto». La cerimonia veniva però improvvisamente interrotta perché «di nuovo dal fondo della galleria si fece sentire il trillo festoso e continuo di campanelli d’argento, e ciò che videro venire innanzi gli occhi del Grande Cerimoniere (…) fu cosa tanto stupefacente da lasciare tutti senza fiato. (..) Avanzava, arrancando con la sua gruccia, il capraro Landino, morto proprio quel giorno nella solitudine del suo tugurio in mezzo ai boschi. (…) E dietro di lui veniva una moltitudine chiassosa di zampette e d’orecchi pelosi, di code ritte e di cornetti aguzzi, pellicce e pelliccette tigrate, setolose, lanute, qua e là strappate e rattoppate alla meglio, gattini rattrappiti e scheletrici, cani bastardi dagli occhi lacrimosi, capretti, daini, camosci, volpi conigli, leprotti dagli stinchi torturati dal morso delle tagliole».
La cerimonia veniva però improvvisamente interrotta perché «di nuovo dal fondo della galleria si fece sentire il trillo festoso e continuo di campanelli d’argento, e ciò che videro venire innanzi gli occhi del Grande Cerimoniere (…) fu cosa tanto stupefacente da lasciare tutti senza fiato. (..) Avanzava, arrancando con la sua gruccia, il capraro Landino, morto proprio quel giorno nella solitudine del suo tugurio in mezzo ai boschi. (…) E dietro di lui veniva una moltitudine chiassosa di zampette e d’orecchi pelosi, di code ritte e di cornetti aguzzi, pellicce e pelliccette tigrate, setolose, lanute, qua e là strappate e rattoppate alla meglio, gattini rattrappiti e scheletrici, cani bastardi dagli occhi lacrimosi, capretti, daini, camosci, volpi conigli, leprotti dagli stinchi torturati dal morso delle tagliole».
Alla vista di Dio, Landino «si lasciò cadere bocconi per terra, con le mani sugli occhi. E tutte le bestiole s’ingegnarono d’imitarlo. Piegando i ginocchi, i loro musetti, le loro narici umide e molli, sfioravano la veste di porpora e d’oro che s’allargava a strascico ai piedi del Signore».
In una breve postilla, Carlo Del Teglio definisce il proprio racconto come «una libera fantasia intorno alla leggendaria figura di Martino I° Della Torre, Signore di Valsassina, detto “il gigante” per la gran mole corporea, quale è tramandata da infiniti cronisti e cultori di storia, antichi e moderni. Tracce di tale tradizione possono cogliersi anche in qualche antico toponimo della Valle. (…) Vano sarebbe invece cercare tracce a indizi dell’esistenza del capraro Landino, ch’è di quei soggetti che la storia terrena ha sempre sdegnato».
Già, gli umili non lasciano tracce. Della crociata valsassinese, invece, qualcosa s’è tramandato, diventando appunto leggenda. Nell’Ottocento, quello che è definito lo storiografo della Valsassina e cioè Giuseppe Arrigoni, nato nel 1811 e morto nel 1867, ne aveva parlato nelle sue “Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe” stampate nel 1840 dalla tipografia milanese di Giacomo Pirola: «La memoria di questo pellegrinaggio dei Valsassinesi in Terra Santa dura tuttavia nella tradizione del volgo, sebbene alquanto alterata nelle circostanze. Essa dice che un Della Torre andò in Palestina alla liberazione del santo sepolcro, che nell’assedio di una città fu il primo a salire sulle mura e togliere ai saraceni l’insegna della mezzaluna, e che, ritornato in patria, ponesse alla terra che abitava il nome di Primaluna, come oggi pure si chiama. Volendo conciliare la tradizione con la storia, si potrebbe affermare che Martino avesse di fatto nell’assedio di Damasco preso pel primo la mezzaluna ai Mussulmani, e che i superstiti Valsassinesi che lo avevan seguito, ritornati da quella spedizione, ponessero un tal nome alla residenza dei Torriani, onde perpetuare la memoria di un tal fatto». E la mezzaluna sarebbe comparsa anche nello stemma gentilizio della famiglia e inoltre «osservisi che quasi sopra ogni porta di stile gotico, che molti ve ne sono in Primaluna, e che si cominciò a usare in quel secolo, vi è scolpita la torre colla mezzaluna. Di più le cinque terre componenti la parrocchia di Primaluna stessa diconsi qualche volta, nel parlar del volgo, la Palestina; e di contro al paese, nel monte Grigna, si erge un altissimo masso che comunemente il Campanile dei Saraceni si appella».
Ma non solo: «Prova infine di quella crociata dei Valsassinesi – scrive ancora l’Arrigoni – è sicuramente la processione dell’entierro, che praticavasi a Primaluna nel Venerdì Santo, poiché sappiamo che i crociati tornati dall’oriente portarono e introdussero tale e consimili funzioni tra noi per dare al popolo un’immagine viva delle meraviglie vedute. Rappresentavansi tutti i tratti della santissima passione del Redentore, e si finiva con una processione, nella quale dodici uomini, che si figurano i dodici apostoli, con ferree catene si percuotevano il nudo dorso. Io stesso li vidi e ne vidi livide le carni ed escirne a rivi il sangue».
Di questa consuetudine avrebbe poi scritto anche anche Pietro Pensa: « Come poi si introdusse la parola spagnola di santo entierro a indicare quel rito non saprei dire; certo è che ai tempi di San Carlo, i più remoti di dominazione spagnola, quel costume era antico e diffuso, tanto che il grande arcivescovo ne decretò l’abolizione “essendo tale consuetudine per la perversità degli uomini scesa a un livello che offende il sentimento di molte persone”. Il divieto venne ripetuto in seguito, ma gli interventi repressivi non riuscirono a soffocare quella che ormai era divenuta una tradizione radicata nella cultura popolare che l’aveva creata. L’entierro più famoso fu dunque quello di Primaluna; giunto a forme di fanatismo religioso, il prevosto, spintovi anche dalle autorità civili austriache, lo abolì intorno al 1840. Da come posso ricostruirlo nel suo svolgimento con le descrizioni pervenutemi dal mio bisnonno Carlo, esso si svolgeva tra la piazza della pievana di San Pietro e la chiesetta di San Rocco e prendeva avvio dalla notte del Getsemani per portarsi al giudizio di Caifa, alla flagellazione, alla salita del Golgota. Attori erano uomini del luogo che ogni anno ripetevano la stessa parte, con accurati e suggestivi costumi realizzati localmente; spettatrice era la gente della valle che giungeva da ogni parte, persino dalla lontana Premana. La recita si concludeva con una processione liturgica generale guidata dal prevosto e dai parroci. Dietro la statua del Cristo deposto venivano dodici confratelli in veste di apostoli, che con catene si percuotevano il nudo dorso. (…) Il suo fascino sulla popolazione della Valsassina e dei dintorni, tuttavia, dovette essere stato forte».















