SCAFFALE LECCHESE/22: da Premana a Venezia con 'Il fabbro e la fortuna' di Del Teglio
«Era stato veramente lui, fabbro e artiere valente, a forgiare e a modellare fino a quel momento la propria vita, o tutto ciò che aveva fatto, pensato, deciso stava già scritto nel libro del suo destino, e lui, d’ogni atto e d’ogni opera, non era stato che un previsto esecutore?». Così si interroga Marsio de’ Lisignoli. Non inganni la particella: non è di sangue blu, ma un figlio di contadini d’alta montagna che lascia la terra per la miniera. E poi, la montagna per il mare: arsenalotto, soldato volontario a Lepanto e altro ancora.

Carlo Del Teglio
L’interrogativo accompagna la narrazione nel libro “Il fabbro e la fortuna”, un “racconto storico della Valsassina del secolo XVI”, come lo definisce l’autore: Carlo Del Teglio che fu docente, poeta e critico letterario per diverse testate. Nato nel 1926 e morto nel 1988. Premanese: all’anagrafe sarebbe stato invero Carlo Codega, forma onomastica a rischio di ilarità per via dei noti “tempi”, ragion per cui scelse un cognome letterario ispirato a una località del paese d’origine, Teglio appunto. E “Il fabbro e la fortuna” è titolo eloquente, laddove “fortuna” ha da essere letta nella duplice accezione di prosperità e destino.La storia prende le mosse proprio da Premana che il nostro preferisce chiamare Pratoalto, ma seminando dettagli e toponimi più che evidenti. Premanese è Marsio. Il quale «dalla magra terra dei monti sapeva che non avrebbe cavato niente… meglio allora la miniera» e a 13 o 14 anni «era salito a fare da garzone alla Cipriana, la vecchia miniera del ferro, in alta Valvarrone». Nel tempo, il ragazzo cambia mansioni, si specializza, diventa un operaio provetto e dopo il lavoro, nelle baracche destinate al riposo, impara a leggere e a scrivere sotto la guida di uno strano personaggio appellato Notajo – non un minatore qualsiasi, ma solo in finale se ne scoprirà la vera identità - che si prende cura della mente e dello spirito del giovane.
Marsio cresce e s’innamora anche, ma è amore destinato al naufragio: lei appartiene a una famiglia di antica nobiltà e non potrebbe che sdegnare gli sguardi di lui, figlio di contadini analfabeti.
Un giorno, all’inizio dell’estate 1570, la ragazza – Caterina – sta salendo all’alpeggio di Caprecolo dove l’aspettano padre e fratello: secondo le regole comunitarie, tocca alla loro famiglia, quel giorno, cuocere il latte nella cascina sociale. Ma ad aspettarla, lungo il sentiero, c’è anche Marsio che le ribadisce i propri sentimenti, le chiede di sposarlo, ma soprattutto le annuncia la partenza all’indomani, «andrò lontano e forse non vi rivedrò più», alla ricerca di vita migliore. Per poi magari – è però il pensiero del giovane – tornare ricco e poter chiedere senza vergogna la mano dell’amata.
E dove potrebbe andare un premanese a cercar fortuna, se non a Venezia? L’emigrazione di fabbri e calderai valsassinesi e premanesi a Venezia è stato un fenomeno importante durato fino all’Ottocento, quando tra calli e campielli si potevano contare oltre un centinaio di botteghe aperte dai valligiani di qua, un movimento che proprio nella seconda metà del Cinquecento iniziava a intensificarsi.
Marsio dunque si reca a Venezia incamminandosi lungo la strada maestra e non verso i valichi montani prediletti da clandestini e fuggiaschi: passa per Lunanuova (che sarebbe Primaluna), scende a Lecco e varca il confine alla Chiusa, non prima di aver dovuto dimostrare al governatore spagnolo le proprie abilità professionali.

Veduta di Premana
Il giovane resta abbacinato dallo splendore della Serenissima. Se Premana è «un branco di catapecchie in pietra viva, dai vecchi intonaci cadenti, i tetti in rozza ardesia tappezzati di muffa, le travature annerite dal fumo» assediate «da fitte selve di castagneti» e abitate da sei o settecento anime, Venezia «per la folta schiera di artisti che in quel tempo vi operavano, per l’apertura e la libertà d’idee e di costumanze, poteva di certo considerarsi l’avanguardia del vecchio mondo europeo». Un paesaggio altro: «A quei tempi correvano per le montagne dell’alta Valsassina lupi ed orsi affamati, che s’udivano la notte ululare e aggirarsi intorno alle stalle e alle case…. Si aggiunga che a far concorrenza a lupi ed orsi, battevano i boschi, in quell’epoca di cronica miseria e di ricorrenti carestie, bande di predoni che dalla pianura salivano a borseggiare i viandanti». L’orizzonte veneziano ora gli si spalanca davanti agli occhi: «La città gli piacque immensamente, così umana e vivace nei suoi rapporti e costumi di vita, così gentile e cantilenante nella voce che si sentiva risuonare nei “campi” e lungo le vie d’acqua, da uscio a uscio, dall’una all’altra finestra, sui toni scanzonati e festevoli dei popolani e dalla gente minuta, che viveva di pesca o di altre piccole attività, non di rado bricconesche». Egli stesso sarà raggirato da una delle tante «cortigiane o meretrici che pullulavano in Venezia e che per la tolleranza delle leggi trovavano la loro patria ideale». Però «anche la Venezia fastosa e splendida delle basiliche, dei monumenti e delle signorili dimore l’incantò e ammirò la bellezza e l’eleganza delle dame, ingioiellate e e avvolte in preziose vesti seriche d’ogni colore e la maestà dei gentiluomini che incontrava passeggiando».Inizialmente sistemato «presso una ferramenta vicino al Ponte della Guerra», trova poi lavoro all’Arsenale, un sogno che s’avvera: «Lì pulsava il vero cuore di Venezia, lì si costruivano ogni giorno la sua potenza e la sua gloria regale».
Proprio in quel periodo, la produzione si concentra sull’attrezzare le navi in vista di future guerre contro i Turchi. Si prepara la storica battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) alla quale il nostro parteciperà come volontario accanto – vedi un po’ i destini - a quel governatore lecchese che poco tempo prima volle saggiarne l’abilità. Ma lasciamo al lettore, il gusto di scoprire avventure e disavventure del protagonista.
A noi non resta che ricalcare la cornice storica così come l’ha disegnata Del Teglio, cornice dentro la quale si avviluppano le vite delle singole persone, vite che possono «dileguare come un filo di nebbia nel mattino. Senza lasciare traccia».
Dei Turchi abbiamo detto. A Venezia dove, morto il doge Pietro Loredan, ci si appresta a eleggere Alvise Mocenigo, «a chi avesse saputo spingere l’occhio al di là della dorata vernice di opulenza e festevolezza che faceva risplendere la vita e la società, allora nel pieno della sua potenza e del suo fasto rinascimentale, non sarebbe stato difficile cogliere i segni d’una inquietudine profonda, d’una serpeggiante preoccupazione. La minaccia turca era più vicina di quanto si facesse trapelare».
Di questa inquietudine per i turchi, chissà quali echi siano arrivati in Valvarrone, forse solo qualche accenno nei sermoni della domenica.
Ma sono anche gli anni dello scontro tra Riforma e Controriforma – e il clima determina alcune delle svolte del libro – gli anni dell’argine al protestantesimo creato sulle Alpi, quasi una grande muraglia di occhi attenti e inquisizioni. Premana, su questo “fronte”, è pienamente coinvolta. Sta proprio lì sulle linee di un confine infido. Oltre il crinale dei monti, oltre la Bocca di Trona dove sgorga il Varrone, c’è la terra delle Leghe Grigie che mezzo secolo dopo sarà teatro di quello passato alla storia come il Sacro Macello.
Quattro anni prima dell’incontro tra Marsio e Caterina sul sentiero per Caprecolo, anche l’arcivescovo Carlo Borromeo era salito in Valsassina fino a Premana a mettere in guardia dall’eresia: «entrato in chiesa seguito dal popolo tumultuante, salì all’altare e si mise a bollare con parole di fuoco la condotta del gregge prostrato ai suoi piedi» e di fuoco saranno anche state le parole dette nel segreto della canonica al parroco don Giacomo Manzoni, non propriamente uno stinco di santo, con qualche debolezza di troppo e qualche altro traffico oscuro. Si ricorderà, nelle direttive del Concilio di Trento c’è anche l’allineamento di un clero secolare troppo spesso inadeguato.
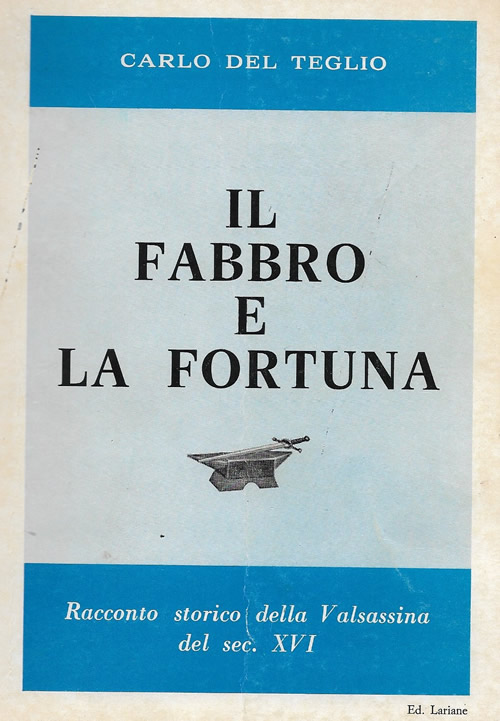
E sarebbe, questa della traslazione, altra vicenda che meriterebbe un racconto a sé . Fu papa Clemente X, nel 1675, a far riesumare dalla catacomba di San Callisto a Roma il corpo di un sant’Ilario martire (la cui biografa peraltro sembra essere svaporata). Le spoglie vennero donate dal cardinale Gaspare Carpegna al veneziano Nicola Venier. Il quale, a sua volta, le affidò nel 1676 ai fratelli Francesco e prete Giacomo Gianola, dimoranti in Venezia ma di “premanesità” indiscussa testimoniata dall’inconfondibile cognome, che le vollero portare nella chiesa parrocchiale del loro paese nativo. Dove arrivarono appunto nel 1678. E ancora oggi sono venerate.

Dario Cercek















