SCAFFALE LECCHESE/219: l'omaggio alla Brianza del casatese Sandro Motta
Nell’abbastanza affollata schiera dei cantori della Brianza o, meglio, della “brianzolitudiine”, va annoverato anche il casatese Sandro Motta, nato nel 1919 e morto nel 1998. Insegnante e traduttore commerciale, poco prima di morire pubblicò il frutto delle ricerche che lo avevano impegnato per una vita.
In un articolo che troviamo nella raccolta di saggi “Il curioso della Brianza” (Bellavite, 2016), lo storico brioschese Domenico Flavio Ronzoni lo ricorda così: «Viveva a Casatenovo (…). Piccolo di statura, i capelli bianchi, la voce sempre più tremula negli ultimi anni, mi riceveva nel suo studiolo, dove gli faceva compagnia un canarino, e cominciava a raccontare, a parlare delle sue storie, si soffermava su una parola del nostro dialetto, su un proverbio, e mi sfidava a spiegarlo, sorridendo soddisfatto quando mi coglieva impreparato e doveva fornirmi la traduzione. Era un po’ il nonno che, seduto accanto al camino, ci raccontava le storie della Brianza di una volta, di cui conosceva in modo raro la vita in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfumature; e di tutto questo ci parlava con una capacità narrativa, intrisa di arguzia e di sottile ironia, che rendeva le sue pagine sempre godibili, anche per l’uso accorto del dialetto, attraverso il quale egli ci sapeva far penetrare nella mentalità profonda dei contadini della nostra terra».
E’ tutta concentrata tra il 1991 e il 1997 la pubblicazione di una serie di libri che costituiscono un vero e proprio scrigno della tradizione brianzola.
Intervistando e registrando per anni, Motta ha salvato dal certo oblio una serie di racconti popolari tramandati oralmente. Racconti che in qualche caso, naturalmente, attingevano anche al patrimonio di leggende dalle radici antiche e di cui questa rubrica si è occupata non molto tempo fa. Ma, per quanto non recidessero i legami con la consuetudine, si trattava sostanzialmente di storie quasi dei nostri tempi, vale a dire dell’ultimo secolo: vicende di fine Ottocento o di inizio Novecento, fino alla Prima guerra mondiale e qualcosa anche nei decenni successivi.
Del resto – spiegava lo stesso Motta - «fino agli inizi degli anni Venti (del Novecento, ndr) sulle nostre colline la “storia” (racconto di vita vissuta) e la “canzon” (racconto fantastico) erano i soli veicoli di comunicazione della cultura della nostra antica gente nelle vicende della vita materiale, sociale, spirituale e fantastica delle campagne». Una narrazione «che ha cessato di esistere con gli anni Quaranta dell’immigrazione e dell’industrializzazione», con un’altra guerra (la seconda mondiale) a fare dunque da ulteriore spartiacque. Si tratta di racconti (o “canzon”) che in alcuni casi Motta ha registrato dalle viva voce di vecchi narratori, in altri ricostruito assemblando quei «pochi ma significativi particolari» che è riuscito a raccogliere.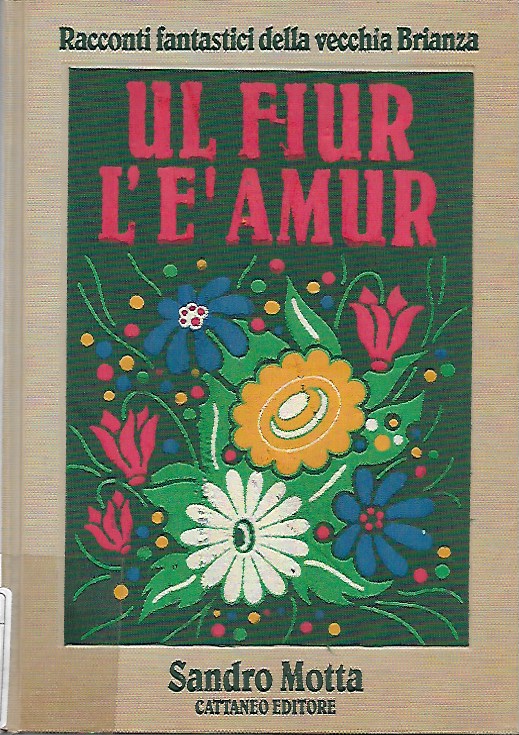 Un bel numero di questi racconti è stato pubblicato in due volumi, editi entrambi da Cattaneo. Il primo uscì nel 1992: “Ul fiur l’è amur. Racconti fantastici della vecchia Brianza”: un centinaio di storie che vedono al centro dell’attenzione i fiori. E’ una maniera per raccontare la religiosità e la cultura di una terra, il suo rapporto con la natura e le differenze di villaggio in villaggio se è vero che anche i fiori, in brianzolo, sono spesso chiamati con nomi differenti secondo le zone. Con una fantasia decisamente sciolta.
Un bel numero di questi racconti è stato pubblicato in due volumi, editi entrambi da Cattaneo. Il primo uscì nel 1992: “Ul fiur l’è amur. Racconti fantastici della vecchia Brianza”: un centinaio di storie che vedono al centro dell’attenzione i fiori. E’ una maniera per raccontare la religiosità e la cultura di una terra, il suo rapporto con la natura e le differenze di villaggio in villaggio se è vero che anche i fiori, in brianzolo, sono spesso chiamati con nomi differenti secondo le zone. Con una fantasia decisamente sciolta.
Si vai mughetti che vogliono vedere Gesù e poi abbassano il capo alla pervinca i cui cinque petali rappresentano le cinque piaghe dello stesso Gesù, dalle coccinelle del guardino di Nazareth che hanno le cipolle quali informatrici al giacinto selvatico conosciuto come il fiore di San Giuseppe. Ma ci sono anche i “peton del luf”, fiorellini gialli nati dalle “arie” di un lupo e che aiutarono San Biagio a ritrovare la strada. Ci sono poi la storia della “paulota” così detta per la sua abbondanza e per essere stata battezzata da San Paolo e quella del “bucasciun”, ovvero il blasfemo che lo stesso diavolo ritiene un po’ esagerato nel suo bestemmiare. Fino a “Zucch e melon… in del so’ canton” e cioè che ogni cosa deve essere piantata al posto adatto. Non solo colta per tempo, dunque, come siamo abituati a dire. Bensì «Zücch e melun minga dumé a la sua stagion, ma anca del so’ canton”.
Il raccontare storie, per Motta, è anche un’occasione per recuperare il dialetto, modi di dire, espressioni destinate a scomparire. E’ dunque una maniera per fissare sulla carta un intero mondo, quello del contadino: il “paisan”, come si chiamava un tempo e cioè il paesano. Facendo tesoro anche di proprie esperienze personali, usi famigliari, ricordi infantili.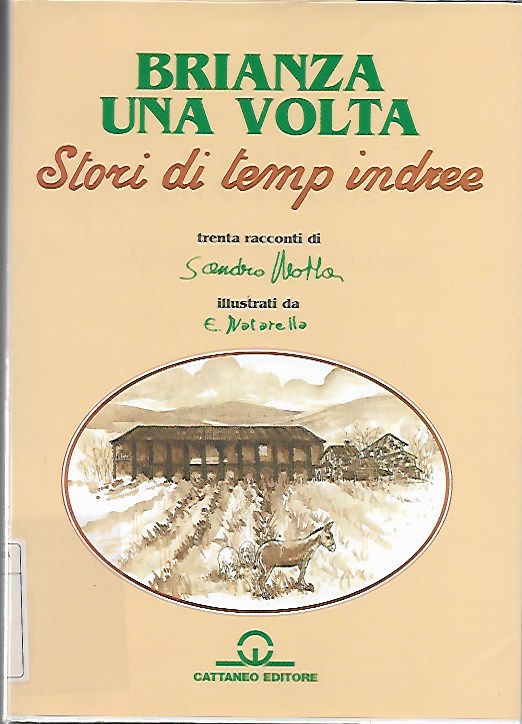 Il secondo volume è invece del 1994: “Brianza una volta. Storia di temp indree”: una galleria di personaggi e vicende spesso ispirati al reale e poi coloriti e colorati dalla fantasia popolare nel corso del tempo. Ed è la rappresentazione di una campagna brianzola popolata dei personaggi i più diversi (i contadini naturalmente, il postino, gli ambulanti, anche i ladri e le prostitute e poi i ricchi e i mendicanti, le autorità, i religiosi) alle prese con la quotidianità più che con avvenimenti eccezionali. Anche se il magico e il misterioso a volte facciano capolino. Autentici artifici narrativi dei quali si servivano anche i “raccontatori” di paese o di cascina; «Nel dialetto delle nostre colline “cascià ball” significa “contarla su”, senza malizia né sottintesi. (…) Con l’andar del tempo la sua sostantivizzazione (“ul casciaball”) assunse inizialmente il significato deteriore di chi racconta fandonie in modo rozzo, sboccato, strafottente, sparandole più grosse di lui. Il casciaball “plebeo” divenne così un protagonista delle bettole di infimo ordine. (…) L’altra faccia del “casciaball” bonaria e non sboccata, propria dello “strascee”, del “ciappee” (stovigliaio), del “masciadro” (merciaio) e di altre categorie di venditori ambulanti (…) era quello che stuzzicava la curiosità delle donne. Di levatura quasi a livello culturale era la figura del “cüntastori” (narratore). Questo strano individuo non era necessariamente un girovago proveniente da altri territori, ma spessissimo un brianzolo dei nostri».
Il secondo volume è invece del 1994: “Brianza una volta. Storia di temp indree”: una galleria di personaggi e vicende spesso ispirati al reale e poi coloriti e colorati dalla fantasia popolare nel corso del tempo. Ed è la rappresentazione di una campagna brianzola popolata dei personaggi i più diversi (i contadini naturalmente, il postino, gli ambulanti, anche i ladri e le prostitute e poi i ricchi e i mendicanti, le autorità, i religiosi) alle prese con la quotidianità più che con avvenimenti eccezionali. Anche se il magico e il misterioso a volte facciano capolino. Autentici artifici narrativi dei quali si servivano anche i “raccontatori” di paese o di cascina; «Nel dialetto delle nostre colline “cascià ball” significa “contarla su”, senza malizia né sottintesi. (…) Con l’andar del tempo la sua sostantivizzazione (“ul casciaball”) assunse inizialmente il significato deteriore di chi racconta fandonie in modo rozzo, sboccato, strafottente, sparandole più grosse di lui. Il casciaball “plebeo” divenne così un protagonista delle bettole di infimo ordine. (…) L’altra faccia del “casciaball” bonaria e non sboccata, propria dello “strascee”, del “ciappee” (stovigliaio), del “masciadro” (merciaio) e di altre categorie di venditori ambulanti (…) era quello che stuzzicava la curiosità delle donne. Di levatura quasi a livello culturale era la figura del “cüntastori” (narratore). Questo strano individuo non era necessariamente un girovago proveniente da altri territori, ma spessissimo un brianzolo dei nostri».
Gli ascoltatori sapevano orientarsi. Più che altro, i problemi sorgevano a volte con il curato, «il quale non gradiva che la testa della gente fosse imbottita di notizie stravaganti che «staven né in ciel né in terra. C’era poi l’eventualità che una contestazione del prete su qualcosa raccontata dalla “saggia della cascina” trovasse schierati tutti i “cassinee” dalla parte della vecchia contro il parroco. D’altronde il prete non aveva tutti i torti nel lamentarsi che i suoi parrocchiani credessero fermamente che l’itinerario della fuga in Egitto della Sacra Famiglia (andata e ritorno) fossero stati i sentieri dei boschi delle nostre colline».
E comunque «campeggia in tutte le vicende la figura del “brianzolo tipo”, con i suoi pregi e i suoi difetti, la sua tendenza un po’ longobarda e le sue manie bizzarre, le sue dabbenaggini ed ingenuità nonché le sue furbizie, anche con la sua bonaria ironia intrisa di un pizzico di malanimo quelle volte che dimenticava di voler bene al prossimo. (…) I cardini dell’“essere brianzolo” (brianzolitudine) sono i seguenti: la Provvidenza, la mentalità contadina e alcune caratteristiche che hanno formato l’indole brianzola (“veia de lavurà, tegnì a man e ves galantomm”, tanto per citare le principali)».
Si parla di amori e omicidi, di atti di generosità, qualche fantasma come “l’umett de Curesciana” e cioè Correzzana che molestava le giovani sole in campagna ma la cui figura era un autentico spauracchio anche per i bambini.
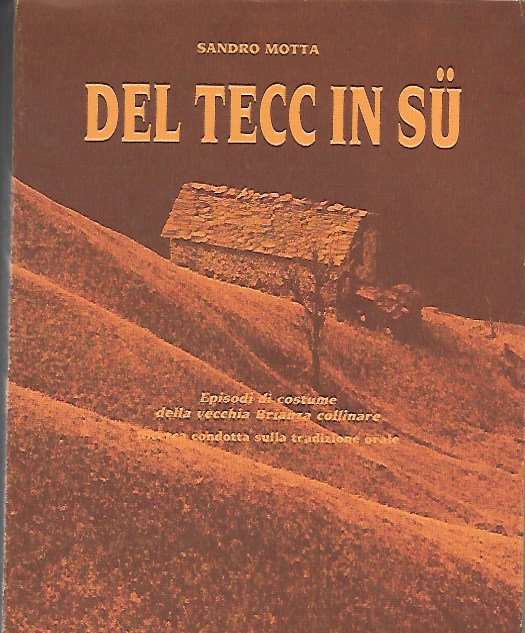
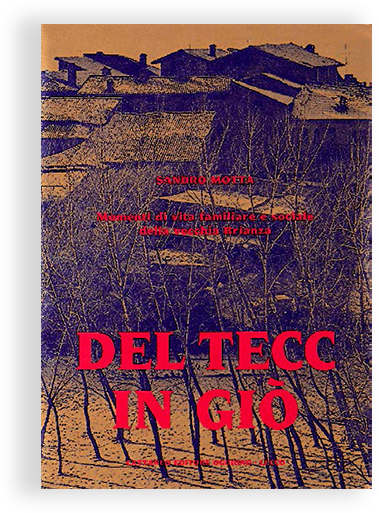 Ai racconti si affiancano altri due libri, pure pubblicati da Cattaneo. Del 1991 è “Del tecc in sü” dedicato al rapporto dei brianzoli con Dio, i santi e la religione. Il libro è strutturato quasi come un annuario. Da gennaio a dicembre, mese per mese, Motta indica le ricorrenze, le feste grandi e quelle piccole, la ritualità, le funzioni, i pellegrinaggi ai santuari, ma anche i giochi, le passioni e il celebrare più profano, fino a episodi accaduti a volte in un passato imprecisato e altre in date ben precise e che sono rimasti nella memoria collettiva attraverso modi di dire che continuano a tramandarsi.
Ai racconti si affiancano altri due libri, pure pubblicati da Cattaneo. Del 1991 è “Del tecc in sü” dedicato al rapporto dei brianzoli con Dio, i santi e la religione. Il libro è strutturato quasi come un annuario. Da gennaio a dicembre, mese per mese, Motta indica le ricorrenze, le feste grandi e quelle piccole, la ritualità, le funzioni, i pellegrinaggi ai santuari, ma anche i giochi, le passioni e il celebrare più profano, fino a episodi accaduti a volte in un passato imprecisato e altre in date ben precise e che sono rimasti nella memoria collettiva attraverso modi di dire che continuano a tramandarsi.
Nel 1993, invece, è arrivato “Del tecc in giò” nel quale lo sguardo è invece rivolto alla vita terrena. E allora la fatica del contadino, il risparmio, l’allevamento dei bachi da seta, il rapporto con gli animali, le figure del prete e del frate cercatore che esisteva davvero e non è solo un personaggio manzoniano, le preghiere, la paura della morte, i sentieri che portano all’inferno e quelli che conducono in paradiso, le superstizioni. E, ancora, il governo della massaia, la “fabbrica dei figli”, la saggezza dei vecchi, il rapporto con il proprio corpo, l’istruzione. O “i quater canton de la cà” che era una maniera di giocare ma che «rappresentavano il congiungimento completo dei quattro lati a formare una comunità unitaria. Idealmente e sentimentalmente i quattro cantoni della casa rappresentavano la buona e la cattiva sorte del ceppo». Ci sono poi “I mee, i toe e i nost”: «All’inizio del secolo (il Novecento, ndr) l’espressione “mio marito e mia moglie” veniva ancora tradotta nel nostro brianzolo collinare comn “ul mè e la mia”. Poi si passò a “ul mè omen e la mia dona” per arrivare a “ul mè marì e la mia miee” e giungere finalmente a “ul mè sciur e la mia sciura”. Si è passati dalla frase affettuosa iniziale ad espressioni molto più “à la page”, ma emotivamente decrescenti, sfociate poi nella sciatta anonimia convenzionale». Infine, i proverbi: dopo un primo volume rilegato uscito nel 1995, hanno fatto seguito due volumi in brossura nel 1997, tutti stampati da Bellavite di Missaglia. In essi, Motta ha raccolto cento proverbi brianzoli, rilevando come troppo spesso le peculiarità linguistiche della Brianza siano state annegate nella più complessiva parlata milanese, nonostante le grandi, grandissime differenze. I cento proverbi scelti da Motta «sono ricorrenti esemplificazioni caratteristiche della nostra area, delle quali parecchie (certamente le più originali) non sono reperibili nelle cosiddette divulgazioni ufficiali. Prendiamo, ad esempio, il concetto che “non tutte le ciambelle riescono col buco”. Il dialetto brianzolo traduce la stessa idea con una inedita immagine da cortile di una cascina missagliese: “Minga de tücc i oev vegn foera ul puresin” (non da tutte le uova nasce il pulcino). Un’espressione dialettale del genere non la si trova in nessun vocabolario milanese! (…) Il contadino brianzolo di inizio del secolo aveva un suo particolare modo di pensare per immagini, tolte esclusivamente dal mondo rurale che lo circondava. Penetrare in questo mosaico di figurazioni contadine è cosa impervia anche per un brianzolo doc».
Infine, i proverbi: dopo un primo volume rilegato uscito nel 1995, hanno fatto seguito due volumi in brossura nel 1997, tutti stampati da Bellavite di Missaglia. In essi, Motta ha raccolto cento proverbi brianzoli, rilevando come troppo spesso le peculiarità linguistiche della Brianza siano state annegate nella più complessiva parlata milanese, nonostante le grandi, grandissime differenze. I cento proverbi scelti da Motta «sono ricorrenti esemplificazioni caratteristiche della nostra area, delle quali parecchie (certamente le più originali) non sono reperibili nelle cosiddette divulgazioni ufficiali. Prendiamo, ad esempio, il concetto che “non tutte le ciambelle riescono col buco”. Il dialetto brianzolo traduce la stessa idea con una inedita immagine da cortile di una cascina missagliese: “Minga de tücc i oev vegn foera ul puresin” (non da tutte le uova nasce il pulcino). Un’espressione dialettale del genere non la si trova in nessun vocabolario milanese! (…) Il contadino brianzolo di inizio del secolo aveva un suo particolare modo di pensare per immagini, tolte esclusivamente dal mondo rurale che lo circondava. Penetrare in questo mosaico di figurazioni contadine è cosa impervia anche per un brianzolo doc».
Altrove, lo stesso Motta annota: «Prendiamo l’immagine del “silenzio”. In italiano la si esprime con “non si sente volare una mosca”. (…) I nostri vecchi collinari realizzavano l’immagine del silenzio dicendo: “Che silenzi! Se sent un cenpee a nà atturno” (si sente un millepiedi camminare). Questa è l’idea collinare del “silenzio”: immediata, precisa, consequenziale!».
Molto è stato scritto sulla valenza dei proverbi. Frasi di circostanza, formule per cavarsi d’impaccio in situazioni di un qualche imbarazzo, motti lenitivi e consolatori, luoghi comuni più che autentiche arguzie, rispecchiano comunque il modo di pensare di una società, quasi a volerne fissare le caratteristiche e le regole e a reiterare un monito. Da parte sua, osservava Motta: «Nella letteratura antica tutte le favole avevano una loro “morale”, vale a dire l’insegnamento che se ne ricavava per migliorare il costume di vita. Per il nostro lavoratore dei campi il proverbio era una specie di compendio etico che gli ricordava il modo di comportarsi per il bene suo e degli altri. L’insegnamento morale dei proverbi appare immediato, incisivo nella sua semplicità e senza possibilità di interpretazioni equivoche».
A rappresentare la Brianza “collinare”, la Brianza “storica” e cioè «le alture che vanno dal Lambro all’Adda e che hanno come epicentro Missaglia», Sandro Motta ha dunque scelto cento proverbi significativi, per ognuno dei quali ci fornisce una vera e propria esegesi, allargando lo sguardo alla società che li ha generati e integrando la spiegazione con un racconto.
Qualche esempio (ricordando che in origine sono in dialetto, per comodità li riportiamo nella versione italiana). «Ua parola di cuscino smuove una macina di mulino», per dire come una parola affettuosa possa smuovere ostacoli ritenuti insormontabili. E «il cuore della donna è fatto come un melone: a chi una fetta, a chi un boccone»; «Quello che conta è esser buono ma non troppo, altrimenti diventi minchione»; «Tra il sì e il no siamo di parere contrario» a proposito degli eterni bastian contrari; «Le case sono fatte di sasso e a toccarle fanno fracasso» per dire di non ficcare il naso in casa d’altri; «Le balle sono buone fino alle undici e mezzo; dopo ci vuole la farina per fare la polenta»; «Son tutti capaci di economizzare quando non ce n’è; bisogna saper risparmiare quando ci sono»; «Il tempo va al trotto fin troppo, ma quello del divertimento va al galoppo». Infine, «per stare in salute, bisogna pisciare come un cane e scorreggiare come un villano»: senza remora alcuna, dunque.
In un articolo che troviamo nella raccolta di saggi “Il curioso della Brianza” (Bellavite, 2016), lo storico brioschese Domenico Flavio Ronzoni lo ricorda così: «Viveva a Casatenovo (…). Piccolo di statura, i capelli bianchi, la voce sempre più tremula negli ultimi anni, mi riceveva nel suo studiolo, dove gli faceva compagnia un canarino, e cominciava a raccontare, a parlare delle sue storie, si soffermava su una parola del nostro dialetto, su un proverbio, e mi sfidava a spiegarlo, sorridendo soddisfatto quando mi coglieva impreparato e doveva fornirmi la traduzione. Era un po’ il nonno che, seduto accanto al camino, ci raccontava le storie della Brianza di una volta, di cui conosceva in modo raro la vita in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfumature; e di tutto questo ci parlava con una capacità narrativa, intrisa di arguzia e di sottile ironia, che rendeva le sue pagine sempre godibili, anche per l’uso accorto del dialetto, attraverso il quale egli ci sapeva far penetrare nella mentalità profonda dei contadini della nostra terra».
E’ tutta concentrata tra il 1991 e il 1997 la pubblicazione di una serie di libri che costituiscono un vero e proprio scrigno della tradizione brianzola.
Intervistando e registrando per anni, Motta ha salvato dal certo oblio una serie di racconti popolari tramandati oralmente. Racconti che in qualche caso, naturalmente, attingevano anche al patrimonio di leggende dalle radici antiche e di cui questa rubrica si è occupata non molto tempo fa. Ma, per quanto non recidessero i legami con la consuetudine, si trattava sostanzialmente di storie quasi dei nostri tempi, vale a dire dell’ultimo secolo: vicende di fine Ottocento o di inizio Novecento, fino alla Prima guerra mondiale e qualcosa anche nei decenni successivi.
Del resto – spiegava lo stesso Motta - «fino agli inizi degli anni Venti (del Novecento, ndr) sulle nostre colline la “storia” (racconto di vita vissuta) e la “canzon” (racconto fantastico) erano i soli veicoli di comunicazione della cultura della nostra antica gente nelle vicende della vita materiale, sociale, spirituale e fantastica delle campagne». Una narrazione «che ha cessato di esistere con gli anni Quaranta dell’immigrazione e dell’industrializzazione», con un’altra guerra (la seconda mondiale) a fare dunque da ulteriore spartiacque. Si tratta di racconti (o “canzon”) che in alcuni casi Motta ha registrato dalle viva voce di vecchi narratori, in altri ricostruito assemblando quei «pochi ma significativi particolari» che è riuscito a raccogliere.
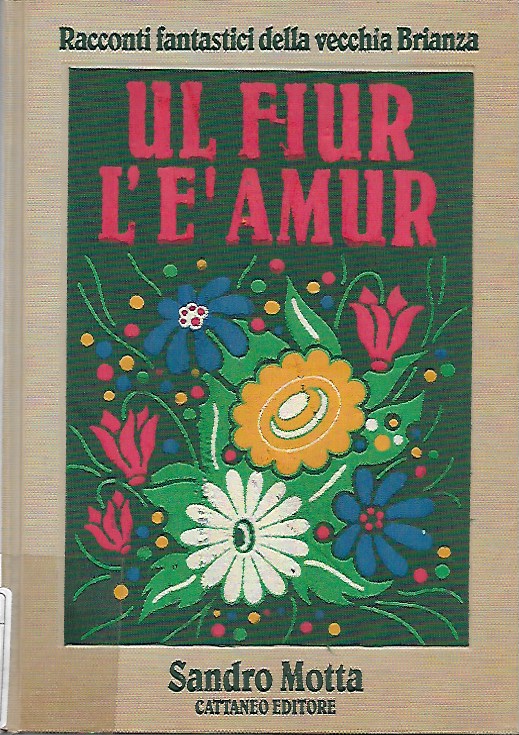
Si vai mughetti che vogliono vedere Gesù e poi abbassano il capo alla pervinca i cui cinque petali rappresentano le cinque piaghe dello stesso Gesù, dalle coccinelle del guardino di Nazareth che hanno le cipolle quali informatrici al giacinto selvatico conosciuto come il fiore di San Giuseppe. Ma ci sono anche i “peton del luf”, fiorellini gialli nati dalle “arie” di un lupo e che aiutarono San Biagio a ritrovare la strada. Ci sono poi la storia della “paulota” così detta per la sua abbondanza e per essere stata battezzata da San Paolo e quella del “bucasciun”, ovvero il blasfemo che lo stesso diavolo ritiene un po’ esagerato nel suo bestemmiare. Fino a “Zucch e melon… in del so’ canton” e cioè che ogni cosa deve essere piantata al posto adatto. Non solo colta per tempo, dunque, come siamo abituati a dire. Bensì «Zücch e melun minga dumé a la sua stagion, ma anca del so’ canton”.
Il raccontare storie, per Motta, è anche un’occasione per recuperare il dialetto, modi di dire, espressioni destinate a scomparire. E’ dunque una maniera per fissare sulla carta un intero mondo, quello del contadino: il “paisan”, come si chiamava un tempo e cioè il paesano. Facendo tesoro anche di proprie esperienze personali, usi famigliari, ricordi infantili.
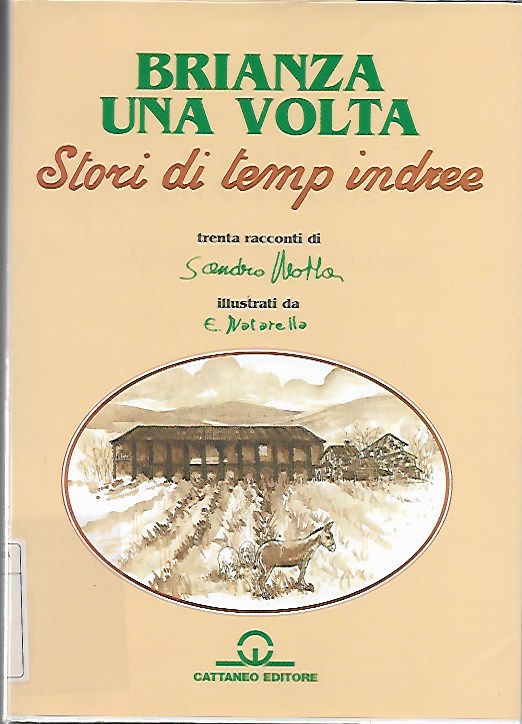
Gli ascoltatori sapevano orientarsi. Più che altro, i problemi sorgevano a volte con il curato, «il quale non gradiva che la testa della gente fosse imbottita di notizie stravaganti che «staven né in ciel né in terra. C’era poi l’eventualità che una contestazione del prete su qualcosa raccontata dalla “saggia della cascina” trovasse schierati tutti i “cassinee” dalla parte della vecchia contro il parroco. D’altronde il prete non aveva tutti i torti nel lamentarsi che i suoi parrocchiani credessero fermamente che l’itinerario della fuga in Egitto della Sacra Famiglia (andata e ritorno) fossero stati i sentieri dei boschi delle nostre colline».
E comunque «campeggia in tutte le vicende la figura del “brianzolo tipo”, con i suoi pregi e i suoi difetti, la sua tendenza un po’ longobarda e le sue manie bizzarre, le sue dabbenaggini ed ingenuità nonché le sue furbizie, anche con la sua bonaria ironia intrisa di un pizzico di malanimo quelle volte che dimenticava di voler bene al prossimo. (…) I cardini dell’“essere brianzolo” (brianzolitudine) sono i seguenti: la Provvidenza, la mentalità contadina e alcune caratteristiche che hanno formato l’indole brianzola (“veia de lavurà, tegnì a man e ves galantomm”, tanto per citare le principali)».
Si parla di amori e omicidi, di atti di generosità, qualche fantasma come “l’umett de Curesciana” e cioè Correzzana che molestava le giovani sole in campagna ma la cui figura era un autentico spauracchio anche per i bambini.
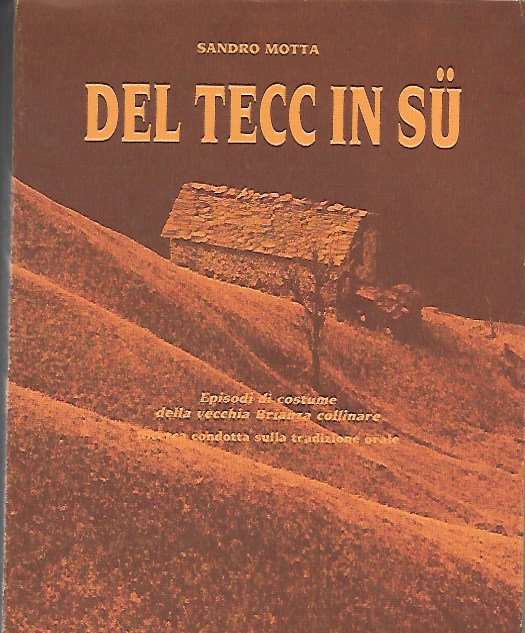
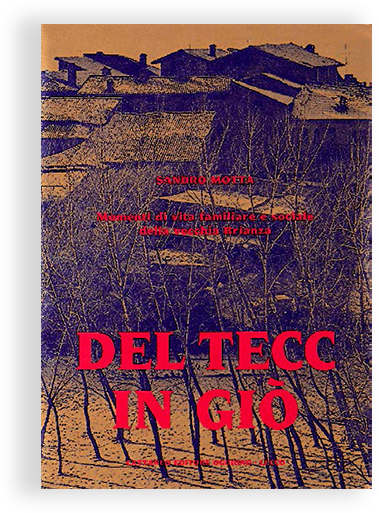
Nel 1993, invece, è arrivato “Del tecc in giò” nel quale lo sguardo è invece rivolto alla vita terrena. E allora la fatica del contadino, il risparmio, l’allevamento dei bachi da seta, il rapporto con gli animali, le figure del prete e del frate cercatore che esisteva davvero e non è solo un personaggio manzoniano, le preghiere, la paura della morte, i sentieri che portano all’inferno e quelli che conducono in paradiso, le superstizioni. E, ancora, il governo della massaia, la “fabbrica dei figli”, la saggezza dei vecchi, il rapporto con il proprio corpo, l’istruzione. O “i quater canton de la cà” che era una maniera di giocare ma che «rappresentavano il congiungimento completo dei quattro lati a formare una comunità unitaria. Idealmente e sentimentalmente i quattro cantoni della casa rappresentavano la buona e la cattiva sorte del ceppo». Ci sono poi “I mee, i toe e i nost”: «All’inizio del secolo (il Novecento, ndr) l’espressione “mio marito e mia moglie” veniva ancora tradotta nel nostro brianzolo collinare comn “ul mè e la mia”. Poi si passò a “ul mè omen e la mia dona” per arrivare a “ul mè marì e la mia miee” e giungere finalmente a “ul mè sciur e la mia sciura”. Si è passati dalla frase affettuosa iniziale ad espressioni molto più “à la page”, ma emotivamente decrescenti, sfociate poi nella sciatta anonimia convenzionale».

Altrove, lo stesso Motta annota: «Prendiamo l’immagine del “silenzio”. In italiano la si esprime con “non si sente volare una mosca”. (…) I nostri vecchi collinari realizzavano l’immagine del silenzio dicendo: “Che silenzi! Se sent un cenpee a nà atturno” (si sente un millepiedi camminare). Questa è l’idea collinare del “silenzio”: immediata, precisa, consequenziale!».
Molto è stato scritto sulla valenza dei proverbi. Frasi di circostanza, formule per cavarsi d’impaccio in situazioni di un qualche imbarazzo, motti lenitivi e consolatori, luoghi comuni più che autentiche arguzie, rispecchiano comunque il modo di pensare di una società, quasi a volerne fissare le caratteristiche e le regole e a reiterare un monito. Da parte sua, osservava Motta: «Nella letteratura antica tutte le favole avevano una loro “morale”, vale a dire l’insegnamento che se ne ricavava per migliorare il costume di vita. Per il nostro lavoratore dei campi il proverbio era una specie di compendio etico che gli ricordava il modo di comportarsi per il bene suo e degli altri. L’insegnamento morale dei proverbi appare immediato, incisivo nella sua semplicità e senza possibilità di interpretazioni equivoche».
A rappresentare la Brianza “collinare”, la Brianza “storica” e cioè «le alture che vanno dal Lambro all’Adda e che hanno come epicentro Missaglia», Sandro Motta ha dunque scelto cento proverbi significativi, per ognuno dei quali ci fornisce una vera e propria esegesi, allargando lo sguardo alla società che li ha generati e integrando la spiegazione con un racconto.
Qualche esempio (ricordando che in origine sono in dialetto, per comodità li riportiamo nella versione italiana). «Ua parola di cuscino smuove una macina di mulino», per dire come una parola affettuosa possa smuovere ostacoli ritenuti insormontabili. E «il cuore della donna è fatto come un melone: a chi una fetta, a chi un boccone»; «Quello che conta è esser buono ma non troppo, altrimenti diventi minchione»; «Tra il sì e il no siamo di parere contrario» a proposito degli eterni bastian contrari; «Le case sono fatte di sasso e a toccarle fanno fracasso» per dire di non ficcare il naso in casa d’altri; «Le balle sono buone fino alle undici e mezzo; dopo ci vuole la farina per fare la polenta»; «Son tutti capaci di economizzare quando non ce n’è; bisogna saper risparmiare quando ci sono»; «Il tempo va al trotto fin troppo, ma quello del divertimento va al galoppo». Infine, «per stare in salute, bisogna pisciare come un cane e scorreggiare come un villano»: senza remora alcuna, dunque.
Dario Cercek















