SCAFFALE LECCHESE/195: streghe, stregoni e superstizioni fra città e Brianza
Con “La donna del gioco”, il romanzo pubblicato un paio d’anni fa e di cui questa rubrica ha dato conto Gianluigi Daccò ci ha ricordato quel poco di memoria che è rimasto di un processo per stregoneria contro alcune donne lecchesi del cui destino, a meno di miracolosi e improbabili scoperte, nulla ormai potremo più sapere.
«E’ risaputo che a Milano nell’estate 1788, per ordine dell’imperatore Giuseppe II, tutti i carteggi che costituivano l’archivio e documentavano cinque secoli di attività dell’Inquisizione milanese e lombarda sono stati bruciati e con essi la possibilità di ricostruire compiutamente il fenomeno della stregoneria e non solo in chiave locale»: così ci informa Natale Perego, autore di “Stregherie e Malefici” pubblicato nel 1993 dalla lecchese Periplo e successivamente nel 2003 per la collezione di “Ricerca di etnografia e storia” dell’editore Cattaneo, libro dedicato a “paure, superstizioni, fatti miracolosi a Lecco e nella Brianza del Cinque e Seicento”. Proprio la distruzione di quei documenti ha messo in ombra la caccia alle streghe avvenuta anche nelle nostre terre, come altrove, tanto più sotto la direzione di quel gran guardiano dell’ortodossia tridentina che fu l’arcivescovo ambrosiano Carlo Borromeo. Il quale nel 1569 inviava una lettera al Sant’Uffizio raccontando appunto di alcune donne lecchesi partecipanti al Sabba e responsabili della morte di persone e bestie. Ed è appunto il caso a cui si riferisce Daccò.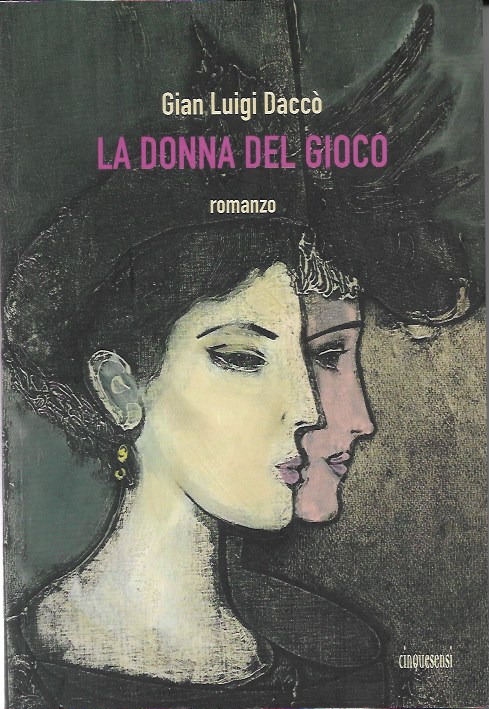 Lo stesso caso, anni prima, aveva intrigato Perego: «Per nulla soddisfatti della mancata conclusione di questa vicenda stregonesca, abbiamo allora indirizzato il nostro interesse a quella che [Angelo] Borghi chiama “diffusissima magia”, perché non si scovano streghe se non c’è una ben precisa volontà inquisitoriale sostenuta dalla certezza che esista una particolare mentalità, una religiosità vissuta quotidianamente al limite del lecito, intessuta di superstizioni o di pratiche magiche».
Lo stesso caso, anni prima, aveva intrigato Perego: «Per nulla soddisfatti della mancata conclusione di questa vicenda stregonesca, abbiamo allora indirizzato il nostro interesse a quella che [Angelo] Borghi chiama “diffusissima magia”, perché non si scovano streghe se non c’è una ben precisa volontà inquisitoriale sostenuta dalla certezza che esista una particolare mentalità, una religiosità vissuta quotidianamente al limite del lecito, intessuta di superstizioni o di pratiche magiche».
Perego dunque esamina il mondo magico lecchese, il patrimonio di cultura e credenze popolari dei quali qualche documento è pur rimasto, analizzando quel mescolarsi di arcaiche usanze pagane e di nuova fede cattolica, i rapporti tra ultraterreno e forze della natura. E, dunque, gli scongiuri contro il cattivo tempo che trasformavano una formula magica in un’invocazione alla Madonna contro il Demonio. C’era poi tutto il “pianeta” della malattia: da un lato anche in questo caso scongiuri e preghiere, dall’altro le terapie e le cure spesso affidate a sapienze popolari e “irregolari” alle quali l’autorità religiosa guardava appunto con lo sguardo sospettoso se non già persecutorio: il trafficare con le erbe, del resto, era indizio di stregoneria, Ma del resto, a quali altri medici poteva rivolgersi un popolano qualsiasi? Che poi, ai tempi, la stessa arte medica che i ricchi potevano permettersi indicava terapie altrettanto “fantasiose”.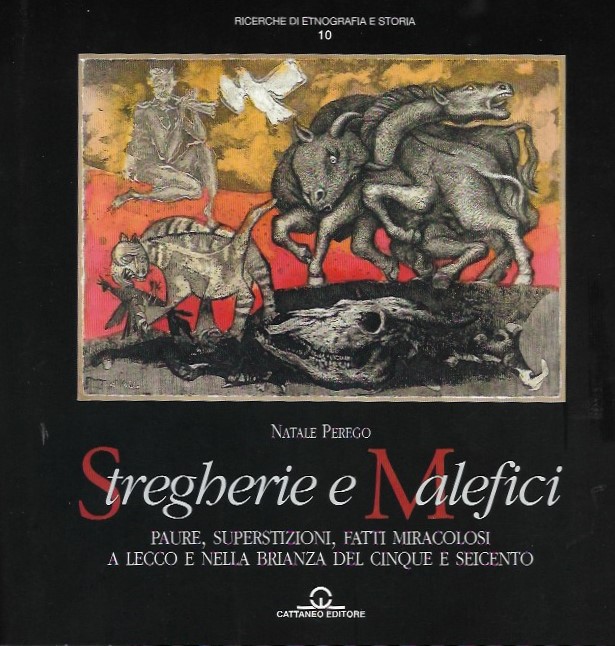 Comprendere quel mondo, per noi oggi, è complesso. In qualsiasi modo lo immaginiamo, non arriveremo mai a percepirne la crudezza così come non avremo mai contezza, per esempio, del buio assoluto e terribile e terrificante delle notti medievali dalle quali tutto e il contrario di tutto sarebbe potuto scaturire. E così del vivere quotidiano di quelle epoche. Per non stupirci, dunque, del ruolo e del peso della magia, della considerazione che alla magia davano non solo gli sprovveduti.
Comprendere quel mondo, per noi oggi, è complesso. In qualsiasi modo lo immaginiamo, non arriveremo mai a percepirne la crudezza così come non avremo mai contezza, per esempio, del buio assoluto e terribile e terrificante delle notti medievali dalle quali tutto e il contrario di tutto sarebbe potuto scaturire. E così del vivere quotidiano di quelle epoche. Per non stupirci, dunque, del ruolo e del peso della magia, della considerazione che alla magia davano non solo gli sprovveduti.
«Anche a Lecco e in Brianza – scrive Perego -, come del resto in tutto lo Stato di Milano, la vita si svolgeva fra profonde incertezze e angosce perché minacciata frequentemente da pericoli e paure individuali che si trasformavano con facilità in collettive. (…) La precarietà della vita trovava nelle guerre, nelle carestie, nelle pestilenze, le sue cause principali. La paura delle malattie aveva obbligato a mettere a punto molteplici scongiuri; l’angoscia di assistere impotenti alla furia della grandine, mentre rovinava i raccolti e causava la miseria, aveva trovato una difesa particolare in rituali; il preminente bisogno di sicurezza personale obbligava a superare ogni esitazione nel puntare l’indice accusatorio contro il vicino. (…) Sono alcuni timori che ci avvicinano al cuore stesso di quel mondo senza tempo e senza limiti proprio della paura; una paura sempre ed ovunque presente, incombente su una realtà terrena animata da presenza inquietanti, da esseri misteriosi, in grado di causare in ogni momento tempeste, dolori, morti. Ma, una su tutte, condizionante, oppressiva, dominava l’immaginario collettivo e teneva costantemente in ansia l’individuo: la paura del demonio. E’ lui l’essere misterioso che sovrastava minaccioso la vita. (…) Non stiamo parlando del diavolo popolare, bonaccione, familiare, quello che si ritrova in tanti racconti del mondo campagnolo e che frequentemente è imbrogliato da un contadino più furbo di lui, il diavolo protagonista di favole che anche le nostre nonne ci hanno raccontato. Parliamo del demonio così come nel corso dei secoli la Chiesa, gli studi teologici l’anno presentato, secondo una versione terrorizzante, senza limiti».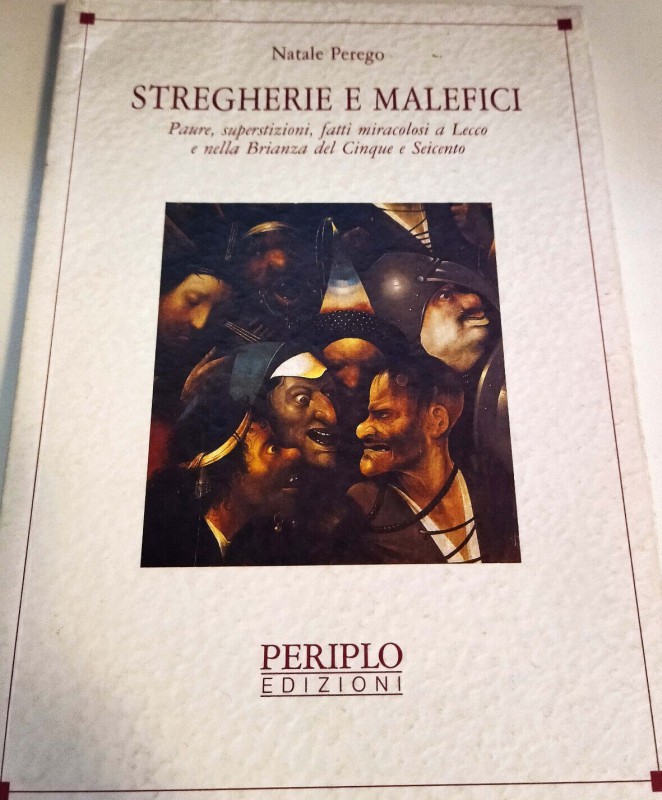 Dobbiamo pensare a queste cose, quando ci imbattiamo nella storia di Galeazio Isacchi che Natale Perego riporta alla luce. Isacchi abita nel piccolo nucleo di Castello dei Perachi sulla strada tra Oggiono ed Ello: è accusato di avere lanciato malefici contro vicini e altre persone di Oggiono causandone in qualche caso addirittura la morte. Nell’anno 1571, il prevosto oggionese, Francesco Frigerio è invitato dai superiori a indagare.
Dobbiamo pensare a queste cose, quando ci imbattiamo nella storia di Galeazio Isacchi che Natale Perego riporta alla luce. Isacchi abita nel piccolo nucleo di Castello dei Perachi sulla strada tra Oggiono ed Ello: è accusato di avere lanciato malefici contro vicini e altre persone di Oggiono causandone in qualche caso addirittura la morte. Nell’anno 1571, il prevosto oggionese, Francesco Frigerio è invitato dai superiori a indagare.
L’accusa di “far malefitij” – ci dice Perego - «si intreccia e si sovrappone al giudizio morale sulla persona di Galeazio, nel tentativo di delinearle un’indole del tutto negativa e di demolirne a reputazione. E’ un uomo triste e cattivo, un furfante, compie azioni ignominiose, è un “rufiano” e per di più ladro, ruba legname, lo commercia e ha insegnato ai figli a rubare. E’ anche debitore nei confronti di due fra i più autorevoli accusatori. E’ possibile che tutto possa essere derivato da questo debito e dall’essere Galeazio realmente un soggetto un po’ asociale, forse un furbastro con poca voglia di lavorare. Di certo una persona fastidiosa, indesiderata e a qualcuno poteva davvero incutere paura. Fin qui però siamo nei limiti delle antipatie personali o poco di più. Ma, nel momento in cui si parla di “malefitij”, tutto acquista un altro valore e le accuse si collocano sul piano del diabolico, il pericolo personale si trasforma in pericolo religioso. La pura nei confronti di Galeazio scatena la fantasia dei vicini, i quali incapaci di dare spiegazioni logiche a certi fatti, a qualche improvvisa disgrazia, si difendono puntano l’indice contro Galeazio. (…) La veridicità di quanto asserito non era vagliata: bastava che un certo episodio fosse riportato da diverse persone per essere creduto vero. Anche la mancanza di una conoscenza diretta del crimine non era causa di inattendibilità perché una cattiva reputazione era già una prova della colpa». Inoltre «Galeazio è un “blasfemator” della peggior specie. (…) Sarebbe incomma la colpa che chiude il cerchio, che inchioda Galeazio alle sue responsabilità». Lo stesso discorso vale per il caso di tale Gio. Antonio Butirone, detto “Bocaletto” che nel 1579 viene segalato dal podestà di Lecco Gregorio Frigneroa a al Senato milanese quale indemoniato e, «tradotto nelle carceri, “li spiriti immundi con stupendi atti e gesti” lo travagliarono, in modo che per sette giorni non poté mangiate, né bere, e perché non morisse fra tanti tormenti fu fatto scongiurare dal prevosto, aiutato da due cappuccini, per sette ore continue».
Lo stesso discorso vale per il caso di tale Gio. Antonio Butirone, detto “Bocaletto” che nel 1579 viene segalato dal podestà di Lecco Gregorio Frigneroa a al Senato milanese quale indemoniato e, «tradotto nelle carceri, “li spiriti immundi con stupendi atti e gesti” lo travagliarono, in modo che per sette giorni non poté mangiate, né bere, e perché non morisse fra tanti tormenti fu fatto scongiurare dal prevosto, aiutato da due cappuccini, per sette ore continue».
Quelli di Galeazio Isacchi e Gio. Antonio Butirone sono probabilmente solo due dei tantissimi casi lecchesi che caratterizzavano quel mondo e quell’epoca e contro i quali era necessaria la massima sorveglianza, una macchina della giustizia e della sicurezza efficiente e attrezzata. Non è un caso, che nel 1565, l’allora prevosto di Castello e primo vicario dell’Inquisizione chiede che vengano costruite due celle da gestire personalmente senza dover passare dalle carceri di Lecco e dal podestà, del quale non si nasconde che è meglio diffidare.
«E’ risaputo che a Milano nell’estate 1788, per ordine dell’imperatore Giuseppe II, tutti i carteggi che costituivano l’archivio e documentavano cinque secoli di attività dell’Inquisizione milanese e lombarda sono stati bruciati e con essi la possibilità di ricostruire compiutamente il fenomeno della stregoneria e non solo in chiave locale»: così ci informa Natale Perego, autore di “Stregherie e Malefici” pubblicato nel 1993 dalla lecchese Periplo e successivamente nel 2003 per la collezione di “Ricerca di etnografia e storia” dell’editore Cattaneo, libro dedicato a “paure, superstizioni, fatti miracolosi a Lecco e nella Brianza del Cinque e Seicento”. Proprio la distruzione di quei documenti ha messo in ombra la caccia alle streghe avvenuta anche nelle nostre terre, come altrove, tanto più sotto la direzione di quel gran guardiano dell’ortodossia tridentina che fu l’arcivescovo ambrosiano Carlo Borromeo. Il quale nel 1569 inviava una lettera al Sant’Uffizio raccontando appunto di alcune donne lecchesi partecipanti al Sabba e responsabili della morte di persone e bestie. Ed è appunto il caso a cui si riferisce Daccò.
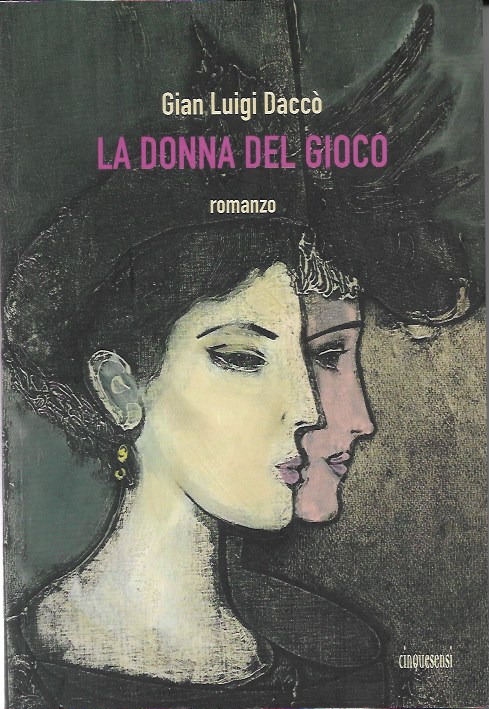
Perego dunque esamina il mondo magico lecchese, il patrimonio di cultura e credenze popolari dei quali qualche documento è pur rimasto, analizzando quel mescolarsi di arcaiche usanze pagane e di nuova fede cattolica, i rapporti tra ultraterreno e forze della natura. E, dunque, gli scongiuri contro il cattivo tempo che trasformavano una formula magica in un’invocazione alla Madonna contro il Demonio. C’era poi tutto il “pianeta” della malattia: da un lato anche in questo caso scongiuri e preghiere, dall’altro le terapie e le cure spesso affidate a sapienze popolari e “irregolari” alle quali l’autorità religiosa guardava appunto con lo sguardo sospettoso se non già persecutorio: il trafficare con le erbe, del resto, era indizio di stregoneria, Ma del resto, a quali altri medici poteva rivolgersi un popolano qualsiasi? Che poi, ai tempi, la stessa arte medica che i ricchi potevano permettersi indicava terapie altrettanto “fantasiose”.
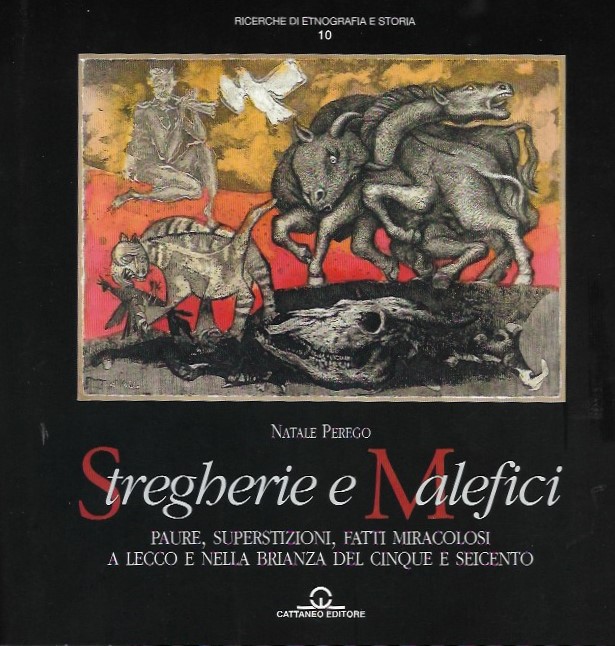
«Anche a Lecco e in Brianza – scrive Perego -, come del resto in tutto lo Stato di Milano, la vita si svolgeva fra profonde incertezze e angosce perché minacciata frequentemente da pericoli e paure individuali che si trasformavano con facilità in collettive. (…) La precarietà della vita trovava nelle guerre, nelle carestie, nelle pestilenze, le sue cause principali. La paura delle malattie aveva obbligato a mettere a punto molteplici scongiuri; l’angoscia di assistere impotenti alla furia della grandine, mentre rovinava i raccolti e causava la miseria, aveva trovato una difesa particolare in rituali; il preminente bisogno di sicurezza personale obbligava a superare ogni esitazione nel puntare l’indice accusatorio contro il vicino. (…) Sono alcuni timori che ci avvicinano al cuore stesso di quel mondo senza tempo e senza limiti proprio della paura; una paura sempre ed ovunque presente, incombente su una realtà terrena animata da presenza inquietanti, da esseri misteriosi, in grado di causare in ogni momento tempeste, dolori, morti. Ma, una su tutte, condizionante, oppressiva, dominava l’immaginario collettivo e teneva costantemente in ansia l’individuo: la paura del demonio. E’ lui l’essere misterioso che sovrastava minaccioso la vita. (…) Non stiamo parlando del diavolo popolare, bonaccione, familiare, quello che si ritrova in tanti racconti del mondo campagnolo e che frequentemente è imbrogliato da un contadino più furbo di lui, il diavolo protagonista di favole che anche le nostre nonne ci hanno raccontato. Parliamo del demonio così come nel corso dei secoli la Chiesa, gli studi teologici l’anno presentato, secondo una versione terrorizzante, senza limiti».
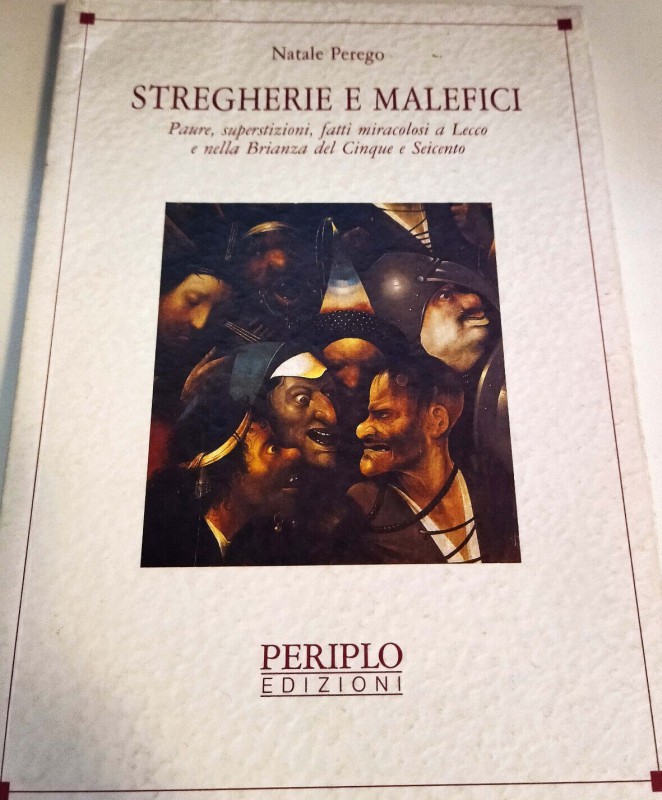
L’accusa di “far malefitij” – ci dice Perego - «si intreccia e si sovrappone al giudizio morale sulla persona di Galeazio, nel tentativo di delinearle un’indole del tutto negativa e di demolirne a reputazione. E’ un uomo triste e cattivo, un furfante, compie azioni ignominiose, è un “rufiano” e per di più ladro, ruba legname, lo commercia e ha insegnato ai figli a rubare. E’ anche debitore nei confronti di due fra i più autorevoli accusatori. E’ possibile che tutto possa essere derivato da questo debito e dall’essere Galeazio realmente un soggetto un po’ asociale, forse un furbastro con poca voglia di lavorare. Di certo una persona fastidiosa, indesiderata e a qualcuno poteva davvero incutere paura. Fin qui però siamo nei limiti delle antipatie personali o poco di più. Ma, nel momento in cui si parla di “malefitij”, tutto acquista un altro valore e le accuse si collocano sul piano del diabolico, il pericolo personale si trasforma in pericolo religioso. La pura nei confronti di Galeazio scatena la fantasia dei vicini, i quali incapaci di dare spiegazioni logiche a certi fatti, a qualche improvvisa disgrazia, si difendono puntano l’indice contro Galeazio. (…) La veridicità di quanto asserito non era vagliata: bastava che un certo episodio fosse riportato da diverse persone per essere creduto vero. Anche la mancanza di una conoscenza diretta del crimine non era causa di inattendibilità perché una cattiva reputazione era già una prova della colpa». Inoltre «Galeazio è un “blasfemator” della peggior specie. (…) Sarebbe incomma la colpa che chiude il cerchio, che inchioda Galeazio alle sue responsabilità».

Quelli di Galeazio Isacchi e Gio. Antonio Butirone sono probabilmente solo due dei tantissimi casi lecchesi che caratterizzavano quel mondo e quell’epoca e contro i quali era necessaria la massima sorveglianza, una macchina della giustizia e della sicurezza efficiente e attrezzata. Non è un caso, che nel 1565, l’allora prevosto di Castello e primo vicario dell’Inquisizione chiede che vengano costruite due celle da gestire personalmente senza dover passare dalle carceri di Lecco e dal podestà, del quale non si nasconde che è meglio diffidare.
Dario Cercek















