SCAFFALE LECCHESE/131: la cucina della tradizione brianzola nell'opera di Bassani
Di Bassani, docente e ricercatore di tradizioni locali, questa rubrica si è già occupata più volte a proposito di dialetto da salvare e di medicamenti popolari.
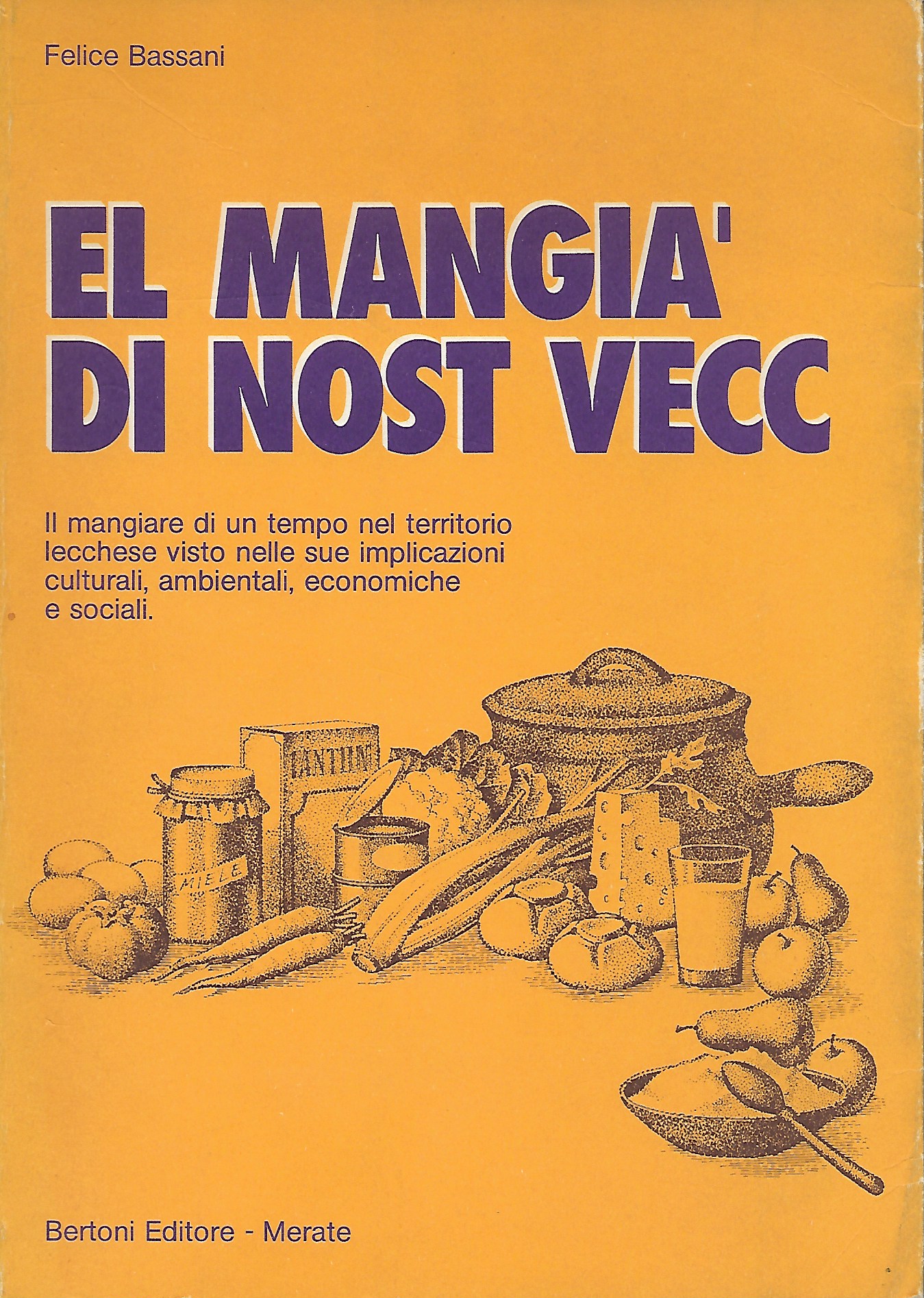
L'autore va poi oltre e ci rammenta come certa cuccagna non fosse poi scontata: «Ricordiamo che il pollame rientrava nei "pendizzi" e doveva essere consegnato in buona parte al padrone: e poteva anche capitare che per il Natale il pollo dovesse essere cucinato di nascosto e non senza rischio, da qualche contadino molto povero che, almeno in quell'occasione solenne, voleva gustarne uno. Chi invece, assolto il "debito" col padrone, di polli ne aveva ancora, per il Natale, amava ostentarli e appenderli, la vigilia, alla porta di casa, con la scusa che, al fresco della notte, si conservavano meglio. Immancabili i commenti e i confronti: "Quello ne ha tre, quell'altro ne ha quattro...". Ma tutti dovevano stare in guardia perché, soprattutto durante la messa di mezzanotte, qualche pollo poteva... prendere il volo».
Questo racconto spiega come le abitudini gastronomiche siano specchio di una società e forniscano materia per ricostruire la storia. Considerazione oggi ovvia: non lo era ancora quaranta e passa anni fa. Il lavoro di Bassani si inserisce in quel grande movimento di cui si è parlato a proposito di altre pubblicazioni: da un lato andava diffondendosi un nuovo modo di fare storia sull'esempio della scuola francese e dell'altra il proliferare di studi locali e la valorizzazione delle testimonianze orali, trattati con criteri più "scientifici" di quanto fatto in precedenza da studiosi o "eruditi" a volte giudicati un po' eccentrici.
Se abbiamo scelto la pagina dedicata al Natale in ossequio al calendario, si sarà capito che il lavoro di Bassani non è una semplice ricerca culinaria, se tale termine è corretto e forse non lo è (non a caso nel libro si preferisce "il mangiare"), bensì un guardare al mondo contadino da un'angolatura particolare, quella appunto della tavola, da quella di tutti i giorni a quella appunto delle feste comandate.
Ed è - ci dice nell'introduzione lo stesso Bassani - un'escursione arricchitasi strada facendo: «Mi ero proposto, originariamente, di presentare ai lettori, interessati all'argomento, il vero "mangiare" tradizionale della nostra gente, immaginando, prima ancora di iniziare le interviste ai "vecchi" della nostra zona, che esso fosse molto diverso da quello propagandato da poco attendibili ricettari o da ristoratori poco informati. Per ristabilire la verità su questo argomento, non potevo però proporre semplicemente un ricettario "diverso". Il "mio" ricettario, per essere credibile, aveva bisogno di "prove", cioè doveva essere sostenuto da un'indagine per quanto serie e approfondita, per cui il modo di mangiare dei nostri vecchi dovesse apparire una naturale

Non sarebbe infatti valsa la pena - aggiunge - affaticarsi in un'indagine del genere se lo sprone fosse stato semplicemente la «curiosità gastronomica, come "cucina" capace di proporre cose e gustose e gradevoli». E vale, invece, «se si vuole intendere il mangiare come espressione di un certo modo di vivere, Infatti, indagando sul "mangià di nost vecc", e sforzandomi di capirlo nelle sue motivazioni, ho praticamente rivissuto, insieme con le persone intervistate, gli aspetti più significativi di una interessantissima cultura: quella della mia gente».
Perché - ci viene ricordato - se il "mangiare" è tema trattato da scrittori di ogni epoca e legato a una "filosofia del piacere" è pur vero che «il "mangiare" è anche e soprattutto l'azione più comune, più necessaria, più inevitabile; e, purtroppo, lo è per tutti, anche per i più poveri, i più miserabili, per i quali, anzi, questa "necessità" è diventata, specialmente in epoche passate, un assillo quotidiano, a volte drammatico».
E allora si comincia dal mangiare e il parlare, dal «parlare come si mangia» tra proverbi e modi di dire, ma anche con un orecchio all'evoluzione della lingua, dal "mangià" che un tempo era "majà"con i vari "majùn" e "majòcch" che ormai riteniamo scomparsi. E si guarda alle tavole e agli usi che sono naturalmente differenti tra montagna e pianura e collina, nelle famiglie contadine e in quelle operaie. Ovunque, tanta polenta naturalmente. Essendo il pane, quello bianco, una rarità. Anche se in Brianza c'era il pane giallo, il "pan de mèj" perché un tempo «il miglio veniva usato al posto della farina gialla, prima che il granoturco si diffondesse nella nostra zona; scomparso il miglio dal pane, è però rimasta la denominazione». Tante minestre e quasi niente carne se non la speranza, come s'è visto, di un pollo o qualcosa di simile per Natale e qualche altra festa solenne. Qualche uova e molta verdura della quale «si poteva disporre in quantità sufficiente, perché gli ortaggi, facilmente deperibili, non erano molto commerciabili e non interessavano granché al padrone» anche se «non dobbiamo pensare a una grande disponibilità di prodotti» e quindi le stesse verdure «venivano consumate con relativa parsimonia e, quando era possibile, si cercava di conservarle in modo da averne a disposizione per tutto l'anno». Poi, naturalmente, c'erano le castagne, il "cibo dei poveri" «poiché crescevano al di fuori delle coltivazioni, nei boschi dove tutti in genere potevano andare a raccoglierle» come attesta un proverbio; «La castagna la g'ha la cua: ce la ciapa l'è sua».
Quali condimenti, burro e strutto, l'olio di oliva c'era ma era per chi poteva permetterselo, i più ricorreva all'olio di ravizzone ("oli de ravisciun") che «era il più diffuso in Brianza. Denso, giallastro, non era certamente un olio pregiato, anche se abbastanza sostanzioso. I pochi che possedevano un torchio servivano una zona molto vasta: i contadini portavano il loro ravizzone (ma non tutti potevano coltivarlo) e ne ricevevano l'olio, una parte del quale veniva lasciato come pagamento per la torchiatura. In alternativa all'olio di ravizzone, c'era l'olio di linosa (semi di lino) e un po' più pregiato ma anche indigesto. A Premana si ricorda l'uso, abbastanza anticamente, dell'olio di noce: non solo per illuminare ma anche per cucinare! Per questa produzione esisteva un frantoio a Margno che serviva una zona abbastanza ampia». A proposito di condimento, «si potrebbe credere che il condimento classico per l'insalata sia sempre stato universalmente l'aceto. In linea di massima è così. Ma a Premana molto spesso l'aceto era sostituito con la "maestra", cioè con il siero della ricotta inacidita».
Il vino di casa era il nostranello che se non era ottimo, pare che almeno in Brianza fosse abbondante. «Nelle osterie, dove gli uomini si recavano la domenica, giorno di riposo, si beveva altro vino, venuto "da fuori", dal Piemonte o dal meridione, e, mentre a casa si beveva con misura, all'osteria capitava de "ciapà la cioca", soprattutto se per le tasche circolava qualche centesimo in più».
In conclusione, Bassani propone anche un ricettario essenziale. Per il risotto di Natale, gli ingredienti sono: riso, lardo, cipolla, brodo, funghi, zafferano. Per il "büsechin" stomaco o intestino d'animale con lardo, cipolla, verdure, acqua e sale ma soprattutto una lenta cottura per quattro o addirittura sei ore...















