SCAFFALE LECCHESE/102: le vicende di Margherita Pusterla raccontate da Cesare Cantù
Come Tommaso Grossi con il suo "Marco Visconti" pubblicato nel 1834, anche Cantù scelse l'epoca viscontea per la sua cavalcata storica, decidendo di raccontare le vicende di Margherita Pusterla, sorella tra l'altro di Ottorino Visconti «sulle cui avventure vi ha fatto piangere un amico mio», scrive l'autore richiamandosi proprio al romanzo del Grossi.
L'occasione per p di "Margherita Pusterla", tale il titolo del romanzo, ci è data da una recente edizione (2021) della milanese "Meravigli". Un'edizione "addomesticata", come spiega la curatrice Ada Grossi: «Samo franchi: la prosa del Cantù è un ostacolo non da poco per la gran parte dei potenziali lettori. (...) "Margherita Pusterla" sfugge al grande pubblico perché non è facile godersi un romanzo dovendo consultare in continuazione tomi d'epoca come il "Vocabolario della Crusca" o il "Dizionario della lingua italiana" del Tommaseo (i quali, oltretutto, non sempre sono sufficienti). Nel pieno rispetto della prosa ottocentesca, dunque, si è ritenuto di addomesticarne alcuni tratti, al fine di farla apprezzare al pubblico di oggi». Operazione che potrebbe far inorridire i puristi, ma è pur vero che gli studiosi hanno pur sempre a disposizione «una qualsiasi delle decine di edizioni precedenti», consentendo però in tal modo al lettore comune «di assaporare fino in fondo une bella storia».

Cesare Cantù cominciò a scrivere il suo romanzo nel 1833 mentre si trovava in carcere, arrestato dal governo austriaco perché sospettato di fare parte della mazziniana Giovine Italia. Per quanto poi scagionato, dietro le sbarre restò undici mesi durante i quali - ci racconta ancora Ada Grossi - «si legge che si fece dell'inchiostro con il fumo delle candele, che usò stuzzicadenti come penna e carta straccia di ogni tipo come fogli».
Il libro venne poi pubblicato nel settembre 1838 dalla tipografia milanese G.Truffi ed ebbe un immediato successo e una lunga fortuna. Ne seguirono infatti decine di edizioni, mentre nel 1841 divenne uno spettacolo teatrale e nel 1856 un'opera lirica, nel 1910 un cortometraggio e nel 1967 un radiodramma.
La vicenda storica su cui si concentra lo scrittore è una pagina della storia della Milano viscontea che forse non si può dire marginale ma sulla quale gli stessi testi di storia milanese non indugiano granché e quel po' di luce caduta sui personaggi si deve proprio al romanzo del Cantù.

E' l'epoca del governo di Luchino Visconti, in particolare nei mesi tra il 1340 e il 1341. Margherita è ella stessa una Visconti, figlia di Uberto e cugina di Luchino: bellissima, sposata a Franciscolo Pusterla: ricchissimo, anzi, «il più ricco dei lombardi», scrive Cantù. Appartiene alla fazione dei nobili milanesi caduti in disgrazia proprio con l'avvento di Luchino al potere. Condizione che non impedisce allo stesso Luchino di insidiare Margherita. Per vendetta o forse semplicemente approfittando di un buon pretesto, il Pusterla ordisce una congiura che viene scoperta e lo costringe alla fuga ad Avignone coi figli, mentre Margherita finisce in carcere. E sarà giustiziata come giustiziati saranno anche Pusterla e i figli catturati con uno stratagemma, oltre ad altri congiurati.
Nel raccontare quegli eventi, il Cantù deve essersi presa qualche licenza, a cominciare dai figli di Margherita e Franciscolo che sarebbero tre e sono ridotti a uno solo nel romanzo. Non abbiamo approfondito oltre, lasciando agli studiosi il compito di verificare l'aderenza alla realtà di alcuni particolari del romanzo. Che ci descrive, per esempio, una Margherita di grande umiltà e ritrosia, quasi monacale, a dirla tutta un po' "lucia" manzoniana. E tale forse non era. Secondo Cantù, delle insidie del cugino vorrebbe tacere proprio per evitare conseguenze irrimediabili. E sostiene, il romanzo, che tutto sommato vera congiura non ci fu, bensì quasi soltanto uno sfogo fra amici in cui si parlò sì di complotto ma per dimenticarsene già all'indomani. Non fosse che un armigero di casa Pusterla, con l'intento di raccattar nuovi adepti, se ne andò invece a raccontare a destra e a manca di un'imminente sollevazione.
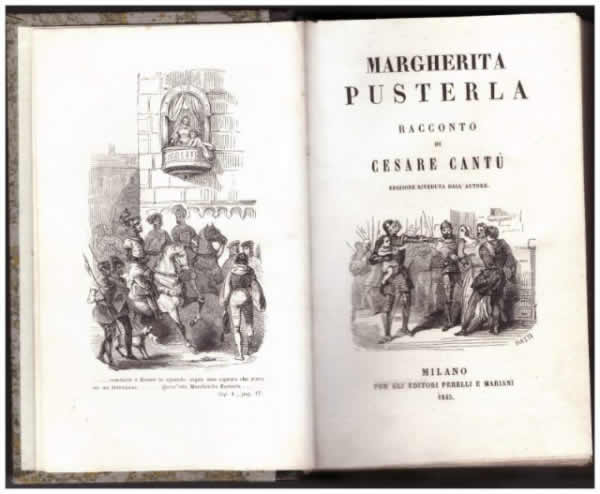
Alla trama principale si intrecciano altre vicende, probabilmente più romanzesche che storiche. Come quella di un Buonvicino perdutamente innamorato della Margherita ancora nubile. Ne sarebbe peraltro ricambiato, ma decide di sacrificarsi per la di lei felicità e farsi frate tra gli Umiliati. Come quella di Ramengo, uno scellerato al servizio di Luchino e in passato aiutante di Franciscolo, quando papà Pusterla governava «il castello di Brivio, un forte eretto a Olginate e la rocchetta di Lecco». A quell'epoca, Ramengo sospettava che Franciscolo trescasse con la propria moglie e che lo stesso figlio appena nato fosse stato in realtà generato da quel rapporto. Decidendo così di disfarsi di consorte e bambino, abbandonandoli su una barca alla deriva sull'Adda. Il figlio si sarebbe salvato e Ramengo l'avrebbe poi incontrato e riconosciuto in circostanze drammatiche. Ma lo sapremo a romanzo ormai avviato alla conclusione.
Attorno a questo, Cantù ricostruisce la società del Trecento. A Milano sembra quasi accompagnarci per mano in una visita guidata della città, descrivendoci luoghi e trasformazioni. Ma non solo Milano: ci parla di Pisa e della Toscana, ci parla di Avignone e di Petrarca del quale non sembra avere gran considerazione. Non tralascia uno sguardo al folklore, alla festa di San Giovanni che «si celebra più o meno solennemente in proporzione alla fede o alla superstizione» e ai suoi legami con la stregoneria. Esce la formazione dello storico. A volte si fa prendere la mano e mette troppa carne al fuoco. Rimpiange l'Italia dei Comuni che fu periodo di rinascita e di libertà civili, finché «caduti quei governi nelle mani di tirannelli, questi ultimi ben si ingegnarono a soffocare quel vivo sentimento di indipendenza». Sarà invece frutto di quanto patito durante i mesi di prigionia la serie di considerazioni sulla giustizia e un raffronto tra il Trecento e suoi tempi, ripetendo come certi arbitrii non siano più possibili avendo la civiltà giuridica fatto passi avanti. E c'è del sarcasmo. A proposito di padri della patria che deliberavano «il meglio, cioè quello che comandavano i forti o insinuavano i più scaltri» o dell'uguaglianza «di fronte alla legge: eguaglianza dalla quale si dovevano però intendere eccettuati i forti, gli scaltri, gli adulatori, il principe, i suoi favoriti e i favoriti dei suoi favoriti» e, ancora, delle differenze che corrono tra giustizia e legalità che è peraltro nodo eterno e tema ancora attualissimo
Se l'impianto storico è robusto, se la trama e gli intrecci tengono, se la narrazione si mantiene su livelli di assoluta dignità, mancano però il guizzo del grande romanziere, l'acuto indimenticabile, le pagine immortali. Pur in presenza di qualche osservazione lapidaria. Per esempio: «Gli uomini son0 gran filosofi nel sopportare le disgrazie altrui e nel consolarsene». O certe considerazioni sul popolo in subbuglio con tanti «destinati a essere per tutta la loro vita, come la maggioranza, null'altro che l'eco delle voci di altri, l'ombra dei gesti di altri» e, una volta esauritosi l'impeto, «al coraggio della paura è subentrata la viltà della sicurezza».

Nel libro si cita pure Lecco, come i è visto. Abbiamo già detto del padre di Franciscolo «il quale, volendo che suo figlio facesse il noviziato delle armi, gli affidò [la rocchetta di Lecco], ponendogli però accanto Ramengo come aiutante. Ciò avveniva nel 1322».
A quell'epoca - racconta il Cantù - Lecco «era poco più che un mucchio di rovine. Poiché si era ammutinato contro i Visconti nel luglio del 1296, il podestà di Milano Giavazzo Salimbene, con i collaterali del capitano e gli stipendiati della Repubblica, cavalcò verso Merate e radunati là molti fanti della Martesana mosse sopra Lecco: ne trasse duecentocinquanta ostaggi che inviò a Milano e poi ordinò che dopo tre giorni tutti i terrieri uscissero dalla città e si portassero a Valmadrera a cielo aperto, con tutte le loro cose, e guai a chi si fosse mosso. Infelici! Dovettero obbedire e di là dal lago videro bruciare la loro patria, di cui rimase solo la rocchetta per tenerli sottomessi: poi udirono pubblicare un bando secondo il quale quel borgo non avrebbe dovuto mai più essere ricostruito».

E abbiamo anche già detto del delitto di Ramengo che s'avventura in barca con moglie e figlioletto ancora lattante partendo riva di Lecco: «Ora Rosalia guardava alle sue spalle il Resegone, dalle cui cime merlate il sole ritraeva gli ultimi raggi; ora, davanti, il varco della Valmadrera, dove la luce tramontando sembrava rifugiarsi. Una volta al largo, «il fellone (...) lanciati in acqua i remi si gettò anch'egli nel lago» lasciando la barca preda in balia della corrente che se la porta lungo l'Adda: giù verso Olginate, Brivio e «fino al luogo che chiamano Sasso di San Michele per via di una chiesuola erettavi dalla timorosa pietà e l'Adda si fa minacciosa e a nulla sembrano valere le grida d'aiuto che la povera donna lancia verso la riva, finché qualcuno lancia una fune che può essere provvidenziale...















