SCAFFALE LECCHESE/68: Balbiani e il romanzo storico coi figli di Renzo e Lucia
Sarebbe un "sequel", come barbaramente s'usa dire di questi tempi: un racconto che prosegue un libro o un film precedenti. Anche se non fu, probabilmente, operazione editoriale alla stregua di quelle che si confezionano oggi in quattro e quattr'otto per sfruttare la scia di un grande successo. Nella fattispecie, la fortuna che arrise ai "Promessi sposi" di Alessandro Manzoni. Nientemeno. Fu più, pensiamo, l'azzardo di un manzoniano sfegatato qual era l'Antonio Balbiani, lo scrittore e giornalista bellanese di cui abbiamo già parlato a proposito delle vicende del bandito Lasco (CLICCA QUI) con una certa sfacciataggine, volle appunto cimentarsi nel seguito del Gran Romanzo pubblicando "I figli di Renzo Tramaglino e di Lucia Mondella". Stampato nel 1875 dall'editore milanese Francesco Pagnoni, il libro non deve essere poi stato un fiasco commerciale, considerate le diverse edizioni successive.

Antonio Balbiani
Certamente, in quell'idea, una qualche genialità c'era. E un po' di presunzione. La struttura vorrebbe essere la stessa dell'opera manzoniana, anche se il Balbiani si lascia decisamente prendere la mano: un romanzo storico con tante, ma proprio tante, digressioni; una storia fatta di tante storie, una gran folla di personaggi dai destini più o meno incrociati. Non manca nemmeno, a completare l'opera nel modo più fedele possibile al gran modello, l'appendice finale della "Storia della famosa peste di Milano, degli Untori e della Colonna Infame nel 1630" con tanto di testimonianza di un barbiere Giangiacomo, discendente per via diretta proprio da quell'altro barbiere Giangiacomo, quello che di cognome faceva Mora e che fu orribilmente giustiziato quale untore nella secentesca peste milanese: «Per lo meno due volte al mese, appena si trova in vena di chiacchierare», il barbiere «spiffera al suo uditorio di Porta Ticinese la storia del contagio, che fu causa del processo e della condanna del bisnonno di suo nonno, che aveva il suo medesimo nome». Naturalmente, il Balbiani non è il Manzoni. Il bellanese tenti l'imitazione. Però, come consuetudine degli scrittori malfermi, appesantisce l'opera per ostentare conoscenze o abbondare in dettagli.
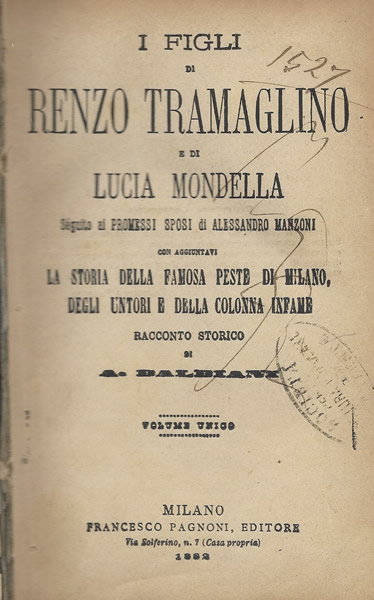
Cucinando così un minestrone un po' indigesto. Detto questo, si potrebbe sorvolare sulle pagine di troppo e pure un po' noiose, chiudere un occhio su talune pretese letterarie, per trovar gusto nella lettura di alcuni passi. Semmai seguendo divertiti il nostro autore nelle sue invenzioni e architetture, anche laddove la scena e le circostanze tenderebbero al tragico. Il Manzoni concludeva il suo romanzo raccontando del ritorno al paesello di Renzo e Lucia guariti dalla peste, del matrimonio che non s'aveva da fare e finalmente celebrato da un don Abbondio in verità ancora un po' recalcitrante, le cui ultime resistenze e scuse cadevano solo ottenuta conferma inoppugnabile del trapasso di don Rodrigo. E che il di lui palazzaccio fosse passato a erede di tutt'altra fatta: deciso, anzi, a risarcire Renzo e Lucia per le angherie subite. La fama delle quali peraltro li avrebbe preceduti nella Bergamasca alimentando pettegolezzi e maldicenze, causa di un ennesimo trasloco. Infine, tutto si accomodava e «prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura (...) e potete credere che le fu messo nome Maria». «Viva la sposa! Viva la sposa!» è l'incipit del romanzo del Balbiani che riprende la narrazione dalle nozze di Renzo e Lucia, dilatando in una decina di capitoli quanto il Manzoni aveva condensato in uno. «Viva la sposa! Viva la sposa!», dunque: sono le «festevoli grida ripetute in coro da varie voci femminili» e che «uscivano, una mattina sulla fine d'agosto dell'anno 1631, dal piccolo cortile che separava una casetta ch'era in fondo, anzi un po' fuori, d'uno dei paeselli sparsi sul lembo estremo della costa del Resegone (...) il paesello dei Promessi sposi». Quasi tre anni dopo da quel 7 novembre 1628 in cui don Abbondio «tornava bel bello dalla passeggiata verso casa». E poi le nozze, il pranzo nel palazzo che fu di don Rodrigo, la conversazione tra il marchese erede e un curato che divaga e divaga.... Balbiani segue passo passo Renzo e Lucia nella loro vita assieme.
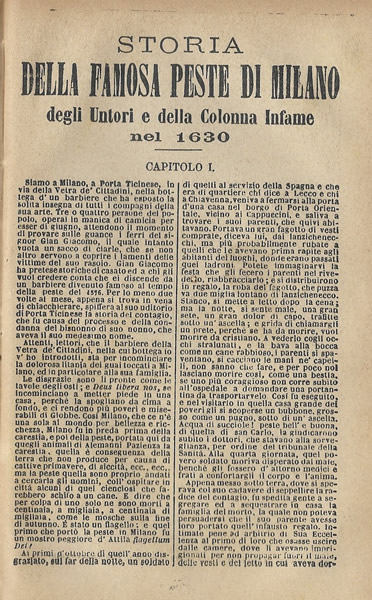
La trama ci racconta dei molti figli: dopo Maria verranno Cristoforo, Nicola (nome del papà di Renzo, ci viene spiegato), Agnesina ma anche un bimbo morto «a quattr'anni d'angina, dopo una filza di rimedi» e ancora una Perpetua e un Abbondio il quale - ma pensa un po' - si farà prete. Ad affollare il racconto compaiono numerosi altri personaggi, vecchie e nuove conoscenze. Compare, un cantastorie chiamato Tabularasa che si presenta a raccontare novelle edificanti, ma che è destinato a una brutta fine: ucciso dopo avere messo incinta una vagabonda. Ricompare quel Nibbio che comandava i bravi dell'Innominato ed è ormai pentito: come un deus ex machina salva da morte certa la piccola Maria e il nipotino di Bortolo che rischiano di finire stritolati nel filatoio. Lo sgherro redento rimane mortalmente ferito: agonizzante, chiederà il perdono di Lucia. Per lettera si fa vivo anche don Abbondio . Quando morirà, al funerale parteciperà tutto il paese, «ma proprio tutti, perché con tutti i suoi difetti di voler sempre aver ragione lui e borbottar sempre, era un galantuomo incapace di far male a una formica»; la sua Perpetua era già morta di peste nel romanzo manzoniano; nella pagine balbianesche, ad assisterlo c'è un'Anastasia che, in eredità, riceverà la mobilia di casa «ma non par contenta perché dice che le andava di diritto anche il resto, non avendo mai avuto un soldo del salario» . Ricompare anche il Sarto, quello che ospitò Lucia una volta liberata dall'Innominato. O, meglio, ne compaiono i figli a salvare il giovane Cristoforo assalito dai briganti, che erano, naturalmente, i banditi della Malanotte. Anni dopo, Cristoforo sposerà proprio una figlia del Sarto. E c'è mamma Agnese che racconta storielle ai nipotini. Di lei, il Balbiani riesce addirittura a squadernare il cognome da nubile, De Divizi.

Ci fermiamo qui. Tra l'altro, ai personaggi in carne e ossa dovremmo aggiungere quelli che balzano fuori dai racconti disseminati tra le pagine a cavallo tra immaginario e storico. E sono una schiera. In quanto alla Storia, sulle vicende di casa Tramaglino si innestano le celeberrime digressioni. La peste di Milano naturalmente e la guerra dei Trent'anni o la monaca di Monza nelle pagine di quel Giuseppe Ripamonti che fu storico e ispirazione per il Manzoni. Ma anche la guerra tra Aragona e Castiglia dell'XI secolo e poi Carlo V, il Medeghino, l'origine dei Bravi, gli Umiliati e la schioppettata a San Carlo. In un romanzo (troppo) pieno di spunti e rimandi, di storie che si intrecciano, Balbiani non ci fa mancare parabole edificanti, storie di contadini miracolati e di contrabbandieri giustiziati, di tribolazioni e meschinità, di vite esemplari e dissolute, di buone azioni e scelleratezze. Tantomeno, le proprie considerazioni e riflessioni. Con qualche tirata moralistica, filippiche sulla famiglia cristiana, discettazioni su scienza e fede. Di atmosfera manzoniana, naturalmente ci sono anche i paesaggi. Con il «sole che indorava le cime ineguali e note dei monti, sorgenti dall'acque ed elevate al cielo», con «il Resegone co' suoi cocuzzoli in fila che lo fanno somigliare ad una immane sega»,ma anche - e sembra prendersi licenza - con il San Martino sul quale «è bello salire per chi ha buoni polmoni, robusti garretti, scarpe indolenti e poca paura del sole e delle vertigini» come aveva fatto un Renzo giovinetto «che v'era salito da Rancio per quel sentiero dirupato, da quadrupedi più che da uomini» senza trascurare il leggendario monastero «dove i vecchi del paese dicevano che, in un tempo, abitassero monache, levate via pel minor male» e non le si poteva «credere voci cattive, dopo la storia della Signora di Monza». Il racconto arriva fino alla morte di Lucia, proprio alla vigilia della prima messa del "novello" don Abbondio (e in futuro pure Agnesina prenderà i voti). Come il Nibbio, anche Lucia in punto di morte ha da chieder perdono per un'ingiustizia commessa nei confronti di una giovanissima filandiera. La scena finale dei "Promessi sposi" manzoniani - si ricorderà - vede Renzo «raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che aveva imparato, per governarsi meglio in avvenire». Aveva imparato, in definitiva, a non cacciarsi nei guai «e certe altre cose», Ma Lucia «non che trovasse la dottrina falsa, ma non n'era soddisfatta» ed era in definitiva che spesso i guai, «la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani». E che «quando vengono, la fiducia in Dio li raddolcisce e e li rende utili per una vita migliore», Analoga è la chiusa del Balbiani. Ormai sepolta Lucia, Renzo rimane «colla corona dei nipoti, ai quali soleva contare le disgrazie e le fortune di casa sua, e conchiudeva che, a questo mondo, il trattar bene è un piatto delicato; la qual sentenza lasciamo per morale dei lettori».
Dario Cercek















