SCAFFALE LECCHESE/62: fra vocabolari e manuali, un excursus sul ''nostro'' dialetto
Chissà. Un giorno saranno soltanto parole scritte in pochi libri. Nei quali libri, tra l'altro, quelle parole non avrebbero dovuto entrare. Perché vive, davvero vive, lo erano soltanto se sospese nell'aria, non messe per iscritto. Per quanto abbiano comunque alimentato una tradizione letteraria con risultati anche eccelsi.
Quanto ci è sempre piaciuto definire la "saggezza popolare" non può essere un sistema di pensiero derivando «da un più o meno evidente differenziarsi della concezione della vita e del mondo nel corso della storia, o per traumi o per lente e naturali evoluzioni: questi diversi "momenti" finiscono col lasciare, quale più quale meno, una traccia indelebile nella comunità». E poi, le contraddizioni e le differenze all'interno della stessa comunità.
Nelle nostre poche righe è impossibile rendere l'idea di tutto quanto è contenuto in quello che è davvero uno scrigno. Soltanto i proverbi saranno un migliaio, non ci siamo presi la briga di contarli. E toccano tutti gli aspetti della vita: la fede, la salute, la morte, il bene e il male, i vizi, i soldi, il mangiare e il bere, l'amore e il sesso, le donne e gli uomini, i libri, la casa, il lavoro, il tempo, il calendario. Le fatiche e i piaceri della vita, dunque. Ma anche il "sedere e la merda" e a questo proposito, Aondio e Bassani sentono il dovere di una postilla: «Ci spiacerebbe se qualche lettore un po' troppo... "raffinato" dovesse storcere il naso di fronte a qualche "volgarità". Ma dobbiamo dire che per i nostri vecchi era piuttosto naturale parlare di questi argomenti anche in famiglia e che i criteri di "decenza" erano un po' diversi rispetto ai nostri. Un tempo si era più ingenui e meno maliziosi, più semplici e meno ipocriti: ogni cosa veniva chiamata col suo nome e il "parlare di grasso" non dava fastidio a nessuno». E allora «quand la barba la ciapa el grisin, sara la pata e tàchet al vin»....
E, davvero, se Aondio e Bassani non le avessero raccolte nel loro libro, la quasi totalità di quel patrimonio sarebbe perduto già oggi. A parte qualche proverbio che ancora sopravvive.
«D'altro canto - leggiamo ancora nella premessa al "Vocabolario lecchese" datata 1992 -le lingue e i dialetti non si impongono; vivono e muoiono indipendentemente dalla nostra volontà» e «i tentativi che da ogni parte in questi anni vengono fatti per ridare dignità e funzionalità ai dialetti sono destinati al fallimento. Le lingue sono come la carta moneta: valgono finché hanno corso legale».
A proposito di carta moneta, ci piace ricordare come, nel dialetto, la lira italiana non esistesse. Si parlava di "franch", franchi: des franch, cent franch, mila franch, eccetera. Curiosa consuetudine mai del tutto chiarita. Ad archiviarla definitivamente ha pensato l'euro.
I dialetti - di questo stiamo parlando - saranno forse, ormai, reperti di "civiltà sepolte". Si vedrà se patrimonio di ristretti circoli frequentati da barbosi professori, quasi un esercizio intellettuale d'élite, o anche di più vaste platee. Popolari. In ossequio alle origini. Qual paradosso, altrimenti, per una lingua che era popolare e che ormai è invece tema di convegni per studiosi, linguisti, storici, ricercatori. Una decina d'anni fa, per esempio, fu il Centro di cultura Paramatti a organizzare una giornata di discussioni a Lecco (gli atti sono stati pubblicati nella rivista "Archivi di Lecco" del settembre 2012).

Circa trent'anni prima, tra il 1975 e il 1976, nell'ambito di un corso universitario venne promossa un'indagine curata dal linguista Emanuele Banfi sulla "resistenza" del dialetto nella nostra città. Emergeva, tra le altre cose, come proprio in quegli anni cominciava a venire meno l'uso del dialetto in ambito famigliare: «Il fenomeno, legato al cosiddetto "salto" generazionale sta alla base dell'abbandono del dialetto da parte dei giovani» per i quali era solo una lingua per poter dialogare con gli anziani. In ciò testimoniando la convinzione di un idioma destinato all'esaurimento. I risultati di quell'indagine vennero raccolti in "Lingua e territorio", opuscolo di lettura un po' ostica pubblicato nel 1979 dalla Biblioteca civica non ancora "Pozzoli".
Non è che si voglia dare per morto il dialetto. Nella lenta agonia di questi decenni, ha infatti avuto non trascurabili sussulti vitali. Addirittura l'era di internet potrebbe alimentare un «cauto ottimismo», stando a quanto premettevano alla seconda edizione del 2001 i compilatori del Vocabolario di Italiano-Lecchese: da un lato «la sempre crescente globalizzazione della società e della cultura ha portato a un rinato interesse per la riscoperta della proprio identità locale per la ricerca delle proprie radici»; dall'altro, «rendere dei contenuti accessibili a un pubblico teoricamente illimitato è diventato una cosa alla portata di chiunque.
Si intravede quindi come, quasi paradossalmente, la società della comunicazione globale offra nuove opportunità anche per la salvaguardia delle parlate locale, sviluppatesi in una società con caratteristiche ben diverse, cioè un mondo prevalentemente rurale in cui la comunicazione era soprattutto orale e le interazioni limitate a un'area geografica relativamente ristretta».
Non è che si voglia dare per morto il dialetto. Nella lenta agonia di questi decenni, ha infatti avuto non trascurabili sussulti vitali. Addirittura l'era di internet potrebbe alimentare un «cauto ottimismo», stando a quanto premettevano alla seconda edizione del 2001 i compilatori del Vocabolario di Italiano-Lecchese: da un lato «la sempre crescente globalizzazione della società e della cultura ha portato a un rinato interesse per la riscoperta della proprio identità locale per la ricerca delle proprie radici»; dall'altro, «rendere dei contenuti accessibili a un pubblico teoricamente illimitato è diventato una cosa alla portata di chiunque.
Si intravede quindi come, quasi paradossalmente, la società della comunicazione globale offra nuove opportunità anche per la salvaguardia delle parlate locale, sviluppatesi in una società con caratteristiche ben diverse, cioè un mondo prevalentemente rurale in cui la comunicazione era soprattutto orale e le interazioni limitate a un'area geografica relativamente ristretta».

Tra l'altro, non è così semplice inquadrare il dialetto del Lecchese, una striscia di territorio che dal Milanese corre lungo l'Adda, si arrampica su per i monti arrivando a toccare la Valtellina dopo avere condiviso confini e scambi economici da una parte con i vicini comaschi e dall'altra con quelli bergamaschi. Con quanto significa nell'evoluzione di una lingua parlata. Se le radici sono milanesi, molto cambia spostandosi da un paese all'altro. Distanze, isolamento, frequentazioni differenti, hanno modellato la lingua nel corso del tempo.
Quante differenze, per intenderci, tra la parlata brianzola e quella valsassinese, tra Osnago e Premana (dove l'indimenticato Antonio Bellati nel 2007 pubblicò un "Dizionario dialettale etnografico" dopo una altre ricerche su una parlato dall'inconfondibile cadenza), ma anche tra un paese brianzolo e l'altro, un paese valsassinese e l'altro. Per intonazioni, accenti, parole acquisite. E così una codificazione appare quasi impossibile, anche se gli esperti sono concordi nell'individuare un'uniformità nella struttura grammaticale.
Si aggiunga la stessa evoluzione, con parole dialettali "pure" che scompaiono, sostituite da altre provenienti dall'italiano e dialettizzate. Il Vocabolario lecchese, ad esempio, per "fragola" riporta sia il tradizionale "magiostra" che un più recente "fragula". Ed è processo che accade sempre più spesso. Quasi a testimoniare, ora che tutti parliamo l'Italiano, il bisogno del dialetto, di una sorta di lingua domestica. Sopperendo a conoscenze perdute col volgere in dialetto le parole della lingua nazionale. E se il declinare di taluni vocaboli può essere un impoverimento, va ammesso che una lingua in divenire è ancora vitale, si adegua ai tempi nuovi e alle necessità.
Quante differenze, per intenderci, tra la parlata brianzola e quella valsassinese, tra Osnago e Premana (dove l'indimenticato Antonio Bellati nel 2007 pubblicò un "Dizionario dialettale etnografico" dopo una altre ricerche su una parlato dall'inconfondibile cadenza), ma anche tra un paese brianzolo e l'altro, un paese valsassinese e l'altro. Per intonazioni, accenti, parole acquisite. E così una codificazione appare quasi impossibile, anche se gli esperti sono concordi nell'individuare un'uniformità nella struttura grammaticale.
Si aggiunga la stessa evoluzione, con parole dialettali "pure" che scompaiono, sostituite da altre provenienti dall'italiano e dialettizzate. Il Vocabolario lecchese, ad esempio, per "fragola" riporta sia il tradizionale "magiostra" che un più recente "fragula". Ed è processo che accade sempre più spesso. Quasi a testimoniare, ora che tutti parliamo l'Italiano, il bisogno del dialetto, di una sorta di lingua domestica. Sopperendo a conoscenze perdute col volgere in dialetto le parole della lingua nazionale. E se il declinare di taluni vocaboli può essere un impoverimento, va ammesso che una lingua in divenire è ancora vitale, si adegua ai tempi nuovi e alle necessità.
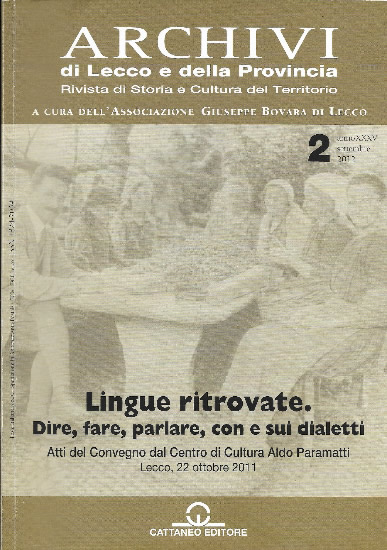
Un punto fermo nella definizione del dialetto lecchese è stata appunto la pubblicazione da parte di Cattaneo Editore del Vocabolario lecchese alla cui stesura hanno collaborato Angelo Biella, Virginia Favaro Lanzetti, Luciana Mondini e Gianfranco Scotti. Uscito nel 1992 è stato poi ripubblicato nel 2001 in una seconda edizione arricchita.
Certo è, come detto, che già negli anni Settanta dello scorso secolo si cominciava a parlare di "dialetto da salvare": tale infatti era il titolo di un libro di poco più di un centinaio di pagine pubblicato con le Edizioni Cattaneo nel 1976 che raccoglieva il frutto delle ricerche di Amanzio Aondio e Felice Bassani. Già l'anno seguente ne uscì una seconda edizione, nel 1983 una terza più corposa e, infine, nel 1999 una quarta ulteriormente integrata. Era di quegli stessi anni Settanta, del resto, l'esplodere dell'attenzione nei confronti della cultura popolare: furono le ricerche effettuate allora a consentire di documentare un patrimonio di canti, di racconti, di fiabe, di costumi e rituali, altrimenti destinato all'eterno oblio. Di questo patrimonio fanno anche parte i proverbi, le filastrocche, le preghiere che Aondio e Bassani andavano in quegli anni raccogliendo tra gli anziani del territorio lecchese, nella consapevolezza «del fatto che quest'opera non può che essere incompleta» e perciò pubblicando, almeno nelle prime due edizioni, il proprio indirizzo con l'invito ai lettori di inviare nuovo materiale.
"Dialetto da salvare", tra l'altro, non è un repertorio asettico di quanto raccolto dai due autori, ma offre un'immagine per certi versi sorprendente - soprattutto per le nuove generazioni che quel mondo non possono ricordare - di una maniera di vivere e pensare, testimoniando una molteplicità di approcci. Come ci viene spiegato: «Una cultura popolare è priva di elaborazione intellettuale, non può presentarsi che in una maniera disorganica, incoerente, asistematica».
Certo è, come detto, che già negli anni Settanta dello scorso secolo si cominciava a parlare di "dialetto da salvare": tale infatti era il titolo di un libro di poco più di un centinaio di pagine pubblicato con le Edizioni Cattaneo nel 1976 che raccoglieva il frutto delle ricerche di Amanzio Aondio e Felice Bassani. Già l'anno seguente ne uscì una seconda edizione, nel 1983 una terza più corposa e, infine, nel 1999 una quarta ulteriormente integrata. Era di quegli stessi anni Settanta, del resto, l'esplodere dell'attenzione nei confronti della cultura popolare: furono le ricerche effettuate allora a consentire di documentare un patrimonio di canti, di racconti, di fiabe, di costumi e rituali, altrimenti destinato all'eterno oblio. Di questo patrimonio fanno anche parte i proverbi, le filastrocche, le preghiere che Aondio e Bassani andavano in quegli anni raccogliendo tra gli anziani del territorio lecchese, nella consapevolezza «del fatto che quest'opera non può che essere incompleta» e perciò pubblicando, almeno nelle prime due edizioni, il proprio indirizzo con l'invito ai lettori di inviare nuovo materiale.
"Dialetto da salvare", tra l'altro, non è un repertorio asettico di quanto raccolto dai due autori, ma offre un'immagine per certi versi sorprendente - soprattutto per le nuove generazioni che quel mondo non possono ricordare - di una maniera di vivere e pensare, testimoniando una molteplicità di approcci. Come ci viene spiegato: «Una cultura popolare è priva di elaborazione intellettuale, non può presentarsi che in una maniera disorganica, incoerente, asistematica».
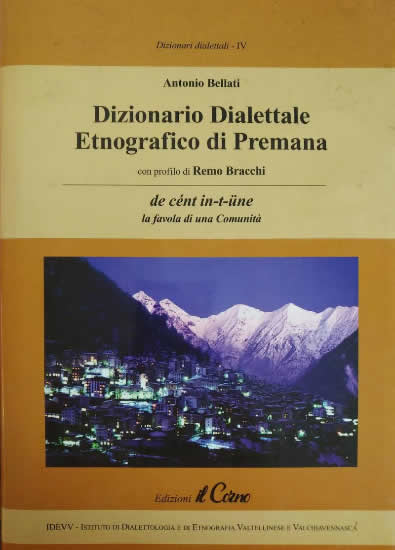
«C'è ad esempio - leggiamo - una religiosità di popolo ingenua, fresca, quasi istintiva, anche se assai spesso permeata di credenze superstiziose, molto diversa da quella organicamente sistemata della normativa ecclesiastica che pure è autorevolmente presente nella comunità; ma c'è anche "l'anti-religione" che si esprime attraverso preghiere contraffatte o composizioni che, ironicamente, beffardamente o umoristicamente, si richiamano alle cose sacre: esse testimoniano un diverso atteggiamento, tutt'altro che raro, nei confronti della religione. Si arriva anche, a volte, ad una certa avversione nei confronti del clero». E citano, ad esempio: «Tri per sett vintün, mort i prévet càntem nün - i prêt coi so balett, i carabigné coi sò manett, tött el mund el sta quet». Dite voi se non è arguzia sopraffina. Con quelle manette dei carabinieri a ricordarci «anche una certa diffidenza popolare (mista a rispetto) per le autorità». Per quanto «i ruoli consacrati dalla tradizione sono accettati acriticamente e con rassegnazione» e «un certo ordine è visto come qualcosa di intoccabile e privo di alternative» seppure «il proprio ruolo subalterno è accettato a volte con una certa naturale insofferenza che rivela uno spirito di ribellione a stento represso». Per esempio, il famoso "vöja de laurà sàltem adoss», ancora utilizzato per dileggio nei confronti degli scansafatiche, avrebbe in realtà un seguito di tutt'altra portata: «laura tè padrun che mé non poss - l'è mej ciapà del lazzarun che andà a cà stracch....».
Naturalmente si trova anche l'esatto contrario, l'invito ad adattarsi, l'etica del lavoro perché il lavorare in allegria è il miglior mestiere che ci sia. Meglio, naturalmente se ben pagato perché «i ball i è ball, ma i danê i è danê». E del resto: «Oh Gesö d'amur accês, fîm vedè i bigliett de dês».
Naturalmente si trova anche l'esatto contrario, l'invito ad adattarsi, l'etica del lavoro perché il lavorare in allegria è il miglior mestiere che ci sia. Meglio, naturalmente se ben pagato perché «i ball i è ball, ma i danê i è danê». E del resto: «Oh Gesö d'amur accês, fîm vedè i bigliett de dês».

Proverbi, dunque. E poi, come detto, le preghiere e le meditazioni tra sacro e profano, le filastrocche scherzose, gli indovinelli, le canzoni, gli appellativi di paesi a partire dagli "scigalott" acquatesi e le espressioni colorite come «Andà a basà ‘l cüü a la vegia» che significa semplicemente «andare a Milano per la prima volta» ed è una lezione di Storia.
Era tutta una sapienza trasmessa oralmente e proprio per questo «tende ad andare perduta, non solo per ragioni formali (la lingua nazionale farà scomparire definitivamente il dialetto), ma anche per ragioni sostanziali (evoluzione naturale e indotta della nostra civiltà)» ed era pertanto necessario - la spiegazione di Aondio e Bassani - raccoglierlo perché restasse «il "senso" della cultura della nostra comunità che sta tutto» nel prendere per il verso giusto «questo mondo che appare così triste e così ingiusto: con un po' di umorismo, con una certa dose di accettazione, con un buon impegno nel lavoro e con molta fiducia nella provvidenza e nell'insegnamento dei vecchi».
Era tutta una sapienza trasmessa oralmente e proprio per questo «tende ad andare perduta, non solo per ragioni formali (la lingua nazionale farà scomparire definitivamente il dialetto), ma anche per ragioni sostanziali (evoluzione naturale e indotta della nostra civiltà)» ed era pertanto necessario - la spiegazione di Aondio e Bassani - raccoglierlo perché restasse «il "senso" della cultura della nostra comunità che sta tutto» nel prendere per il verso giusto «questo mondo che appare così triste e così ingiusto: con un po' di umorismo, con una certa dose di accettazione, con un buon impegno nel lavoro e con molta fiducia nella provvidenza e nell'insegnamento dei vecchi».
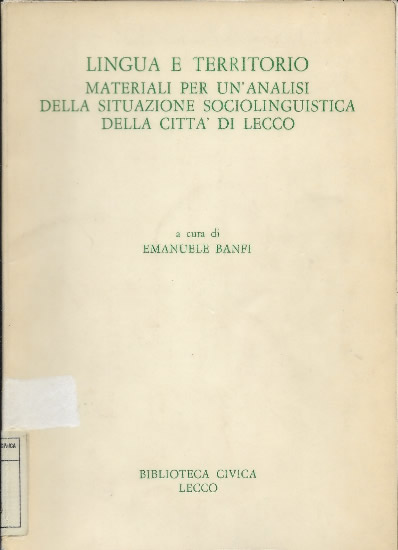
«D'altro canto - leggiamo ancora nella premessa al "Vocabolario lecchese" datata 1992 -le lingue e i dialetti non si impongono; vivono e muoiono indipendentemente dalla nostra volontà» e «i tentativi che da ogni parte in questi anni vengono fatti per ridare dignità e funzionalità ai dialetti sono destinati al fallimento. Le lingue sono come la carta moneta: valgono finché hanno corso legale».
A proposito di carta moneta, ci piace ricordare come, nel dialetto, la lira italiana non esistesse. Si parlava di "franch", franchi: des franch, cent franch, mila franch, eccetera. Curiosa consuetudine mai del tutto chiarita. Ad archiviarla definitivamente ha pensato l'euro.
Dario Cercek















